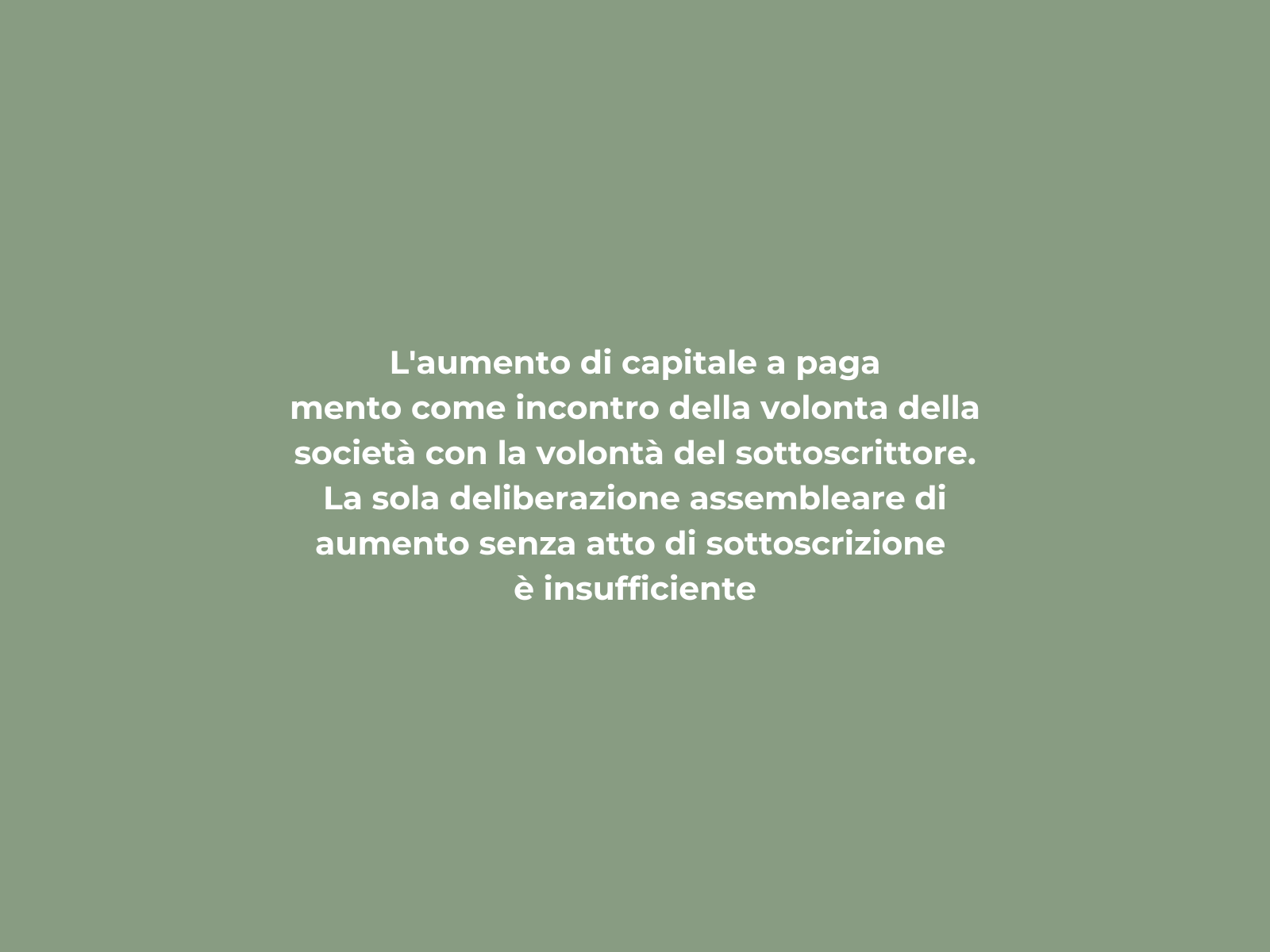Parte della dottrina ha in passato sostenuto che «con la delibera di aumento del capitale si pone in movimento un procedimento finalizzato a modificare istituzionalmente (mediante l’organismo assembleare) l’atto costitutivo della società, secondo regole predisposte dalla legge e, nei limiti consentiti, dalla stessa delibera. Si tratta dunque di un atto di auto-regolamento societario che rispetto all’atto di sottoscrizione di ciascun socio si pone come regola programmatica1 . Per utilizzare l’immagine di coloro i quali un tempo sostenevano che l’accordo contrattuale implica l’incontro della volontà di due o più parti, si potrebbe osservare che la volontà del sottoscrittore non si incontra con quella della società, poiché mentre questa, con la delibera di aumento del capitale sociale mira a stabilire le regole per realizzare tale aumento, la volontà del sottoscrittore mira invece ad acquistare le partecipazioni di nuova emissione esercitando quel diritto di opzione/sottoscrizione che la legge, in caso di aumento del capitale riconosce a chi è già socio della società proprio quando quest’ultima delibera l’aumento2» .
Secondo detta dottrina non vi sarebbe «incontro di volontà tra la delibera di aumento e sottoscrizione del socio così come non vi è accordo contrattuale, per fare un altro esempio emblematico, tra la volontà del testatore e l’accettazione3» .
Non si tratterebbe, pertanto, di nuova e autonoma fattispecie contrattuale, bensì di manifestazione di volontà di finanziamento conseguente all’originario contratto di società. La sottoscrizione sarebbe atto unilaterale di esercizio del diritto di opzione/sottoscrizione, costituente esercizio di un diritto potestativo, ossia di un atto dichiarativo privo di efficacia negoziale, perché gli effetti che la legge ricollega all’atto non sono derogabili o modificabili dalla volontà di chi compie l’atto.
L’aumento del capitale sociale non sarebbe, per detta dottrina, l’effetto di un contratto bensì di un procedimento.
Non troppo dissimile sembra la ricostruzione di altra dottrina che, inserendosi nel filone interpretativo della dottrina appena citata, ritiene inaccettabile ricostruire l’aumento a pagamento in termini di proposta e accettazione e sostiene che la sottoscrizione dell’aumento di capitale rappresenterebbe sotto il profilo negoziale “l’atto di adesione al contratto sociale non potendo scindersi, nelle società di capitali, dalla manifestazione di volontà di costituire la società: e cioè non un contratto autonomo, bensì uno degli elementi del contratto di società, paragonabile, metaforicamente, alla somma nella vendita, e cioè alla determinazione quantitativa della prestazione dell’acquirente4” . Secondo questa tesi la sottoscrizione del capitale da parte (principalmente) del socio non potrebbe considerarsi né accettazione di una proposta, né tantomeno atto di adesione al contratto aperto, visto che essa rappresenterebbe l’atto “con il quale si modifica quantitativamente la propria adesione alla società, ovvero se ne entra a far parte attraverso una modificazione della compagine sociale assolutamente differente da quella dell’art. 1332 c.c.: l’atto costitutivo (e lo statuto) non si modifica attraverso altro contratto, bensì attraverso il peculiare meccanismo deliberativo; d’altra parte ogni modificazione della compagine sociale lascia inalterato il contratto originario. Ciò basta a escludere dal fenomeno ogni possibilità di applicazione dell’art. 1332, c.c.5 .
La logica conseguenza di quanto affermato si rinviene in una pronuncia di una Corte di merito (App. Bari, inedita, poi cassata dalla Suprema Corte)6 secondo cui il socio non potrebbe assumere validamente l’obbligo di sottoscrivere l’aumento di capitale prima dell’approvazione della delibera di aumento, costituendo quest’ultima, alla luce dell’art. 2481-bis, c.c., presupposto indispensabile per la nascita del diritto d’opzione/sottoscrizione.
Conseguenza di tale asserzione sarebbe ritenere possibile prima della deliberazione di aumento esclusivamente un “conferimento anticipato” ma non una sottoscrizione anticipata con la conseguenza che in sede di aumento del capitale (contestualmente o dopo) occorrerà che il socio emetta un’espressa “dichiarazione di sottoscrizione”.
Così sembra pronunciarsi anche parte della dottrina allorchè afferma che “i versamenti in conto futuro aumento di capitale…si traducono in realtà nel (mero) pagamento anticipato del prezzo di un’aliquota del capitale non ancora emessa né, tanto meno, sottoscritta dal socio7” .
Sembra preferibile ritenere che l’aumento del capitale sia un vero e proprio contratto tra società e sottoscrittore con il quale si aggiungono nuove partecipazioni sociali a quelle già esistenti (nel caso di sottoscrizione preferenziale da parte dei già soci) o si acquisiscono nuove partecipazioni sociali (nel caso di sottoscrizione da parte di terzi)8 , e più precisamente, si deve ritenere che “la sottoscrizione della quota di s.r.l. sia un “atto negoziale e precisamente un contratto consensuale in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare9” .
La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che “l’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma con il concorso delle volontà dell’ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento del capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l’incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci, ovvero, se prevista anche dei terzi. Tale dichiarazione si manifesta, appunto, con la sottoscrizione di una quota dell’aumento deliberato10” .
Infatti, la deliberazione è: un atto unilaterale collegiale, perché emanazione di un unico centro di interessi o parte, la società personificata; pluripersonale, perché promanante da più soggetti, i soci, costituenti unica l capiparte in quanto formano tutti insieme un organo della società, l’assemblea; collegiale, perché diretto a formare attraverso l’unificazione delle diverse dichiarazioni di volontà dei singoli la dichiarazione di volontà di altro soggetto (l’assemblea); manifestazione del principio di maggioranza, perché la dichiarazione è espressione della maggioranza dei partecipanti all’assemblea, la quale con la sua formulazione determina la formazione della deliberazione, considerata per forza di legge espressione anche della minoranza dissenziente.
È quindi incontestabile che la deliberazione tende alla formazione della volontà di un soggetto diverso dalle persone autori delle dichiarazioni di maggioranza.
Una pronuncia della Suprema Corte11 ha avuto modo di affermare che la deliberazione di aumento del capitale esprime la volontà sociale di acquisire nuovo capitale di rischio, ma non implica che tale capitale sia effettivamente acquisito (neppure sotto forma di credito per la riscossione dei relativi versamenti) fin quando la deliberazione stessa abbia avuto effettiva esecuzione, ossia fino al momento in cui i soci titolari del diritto di opzione (o eventualmente i terzi, se il diritto di opzione non venga esercitato) abbiano sottoscritto l’aumento di capitale deliberato12 .
La Suprema Corte ha precisato che la deliberazione di aumento del capitale rappresenta “un atto di organizzazione interna alla società, per il quale il potere è di regola riservato all’assemblea dei soci, chiamata ad esprimere la volontà della società attraverso i quorum e le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. Questa funzione organizzativa interna della deliberazione di aumento del capitale, che implica tra l’altro una modificazione statutaria, non esclude tuttavia una diversa concorrente funzione, assimilabile ad una vera e propria proposta negoziale, indirizzata ai soci o ai terzi secondo la diversa incidenza del diritto di opzione nei diversi casi che possono darsi, e avente ad oggetto una partecipazione, o una maggiore partecipazione al capitale della società; una funzione, dunque, che non si esaurisce all’interno della società, ma è diretta all’instaurazione di rapporti intersoggettivi (tali sono anche quelli con i soci, in quanto autori di nuovi conferimenti)13” . L’aumento del capitale sociale non sarebbe, pertanto, un mero atto della società, rendendosi, viceversa, necessario l’incontro tra la volontà della società, manifestata attraverso la delibera di aumento, e la volontà dei nuovi contraenti, siano essi i nuovi sottoscrittori, ovvero i vecchi soci14 .
Secondo la giurisprudenza la deliberazione di aumento del capitale non è self executing, non essendo idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale, ma necessita, ai fini della sua attuazione, della conclusione dei negozi di sottoscrizione, per mezzo dei quali, “il sottoscrittore si obbliga ad eseguire un determinato conferimento, il quale costituisce l’atto di esecuzione dell’obbligo assunto a partire dalla sottoscrizione15
La deliberazione assembleare di aumento del capitale va quindi tenuta distinta dall’atto dii sottoscrizione che i soci e/o i terzi eventualmente facciano del capitale di cui si è deliberata la proposta di aumento. Infatti, “la deliberazione assembleare esprime la volontà negoziale (della società) di acquisire nuovo capitale di rischio, ma è necessario che la deliberazione abbia effettiva esecuzione e cioè che i soci, titolari del diritto di sottoscrivere l’aumento, o eventualmente i terzi, se ed in quanto previsto, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dei soci, abbiano sottoscritto l’aumento di capitale deliberato, indipendentemente dal fatto che in sede assembleare abbiano o meno votato per l’aumento di capitale16. Dal punto di vista del socio, ciò sta a significare che, indipendentemente dall’avere egli concorso o meno col proprio voto alla deliberazione di aumento del capitale, è solo per effetto di una successiva e ben distinta manifestazione di volontà, consistente appunto nella sottoscrizione della quota parte del nuovo capitale offertogli in opzione, che egli assume verso la società il relativo obbligo di versamento, ove non vi abbia già provveduto per intero contestualmente alla sottoscrizione stessa17
Ne discende che la società ha l’onere di provare non solo l’esistenza della deliberazione assembleare di aumento del capitale, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell’aumento medesimo ad opera di detto socio.
Ai più detta affermazione può sembrare di palmare evidenza. È chiaro, infatti, che altro è la volontà espressa in assemblea dal socio altro la volontà espressa dal socio come sottoscrittore dell’aumento18 .
L’affermazione, però, diventa meno scontata se si tiene conto da un lato della libertà di forma del contratto di sottoscrizione dell’aumento19 , dall’altro dell’erosione del principio di realità del contratto di sottoscrizione, conseguenza di quell’orientamento che ritiene non essenziale per il perfezionamento del contratto di sottoscrizione il versamento del 25% della somma sottoscritta20 .
A ciò si aggiunge, infine, il proliferare di dazioni di somme dal socio alla società, spesso non accompagnate da una chiara e certa qualificazione. Si tratta dei cosiddetti apporti anomali realizzati dai soci. Tali dazioni spesso come si preciserà in seguito accompagnano l’atto di sottoscrizione che può anche logicamente precedere la decisione societaria di aumentare il capitale sociale21 , assumendo in questo caso il significato di una proposta del socio rispetto alla quale la delibera assembleare vale, correlativamente, da accettazione idonea a completare la fattispecie negoziale.
Alla luce di quanto affermato è, pertanto, indicativa di un maggior rigore nell’accertamento dell’effettivo perfezionarsi del contratto di sottoscrizione dell’aumento di capitale la pronuncia di una Corte di merito22 secondo la quale pur non potendosi disconoscere il carattere consensuale e non formale del contratto di sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale, in mancanza di una dichiarazione espressa, la volontà di sottoscrivere deve essere provata in base ad indici probatori concordanti, non essendo sufficiente il rilascio di assegni intestati alla società, a fronte di un aumento del capitale sociale a pagamento già deliberato. In tale direzione muove anche un’altra pronuncia giurisprudenziale laddove afferma che la deliberazione di aumento non ha fatto acquistare la qualità di socio e il requisito formale della sottoscrizione non può essere “surrogato” da prospettate partecipazioni dell’ipotetico soggetto entrante in società alla formazione degli organi sociali e alla gestione futura della società23.