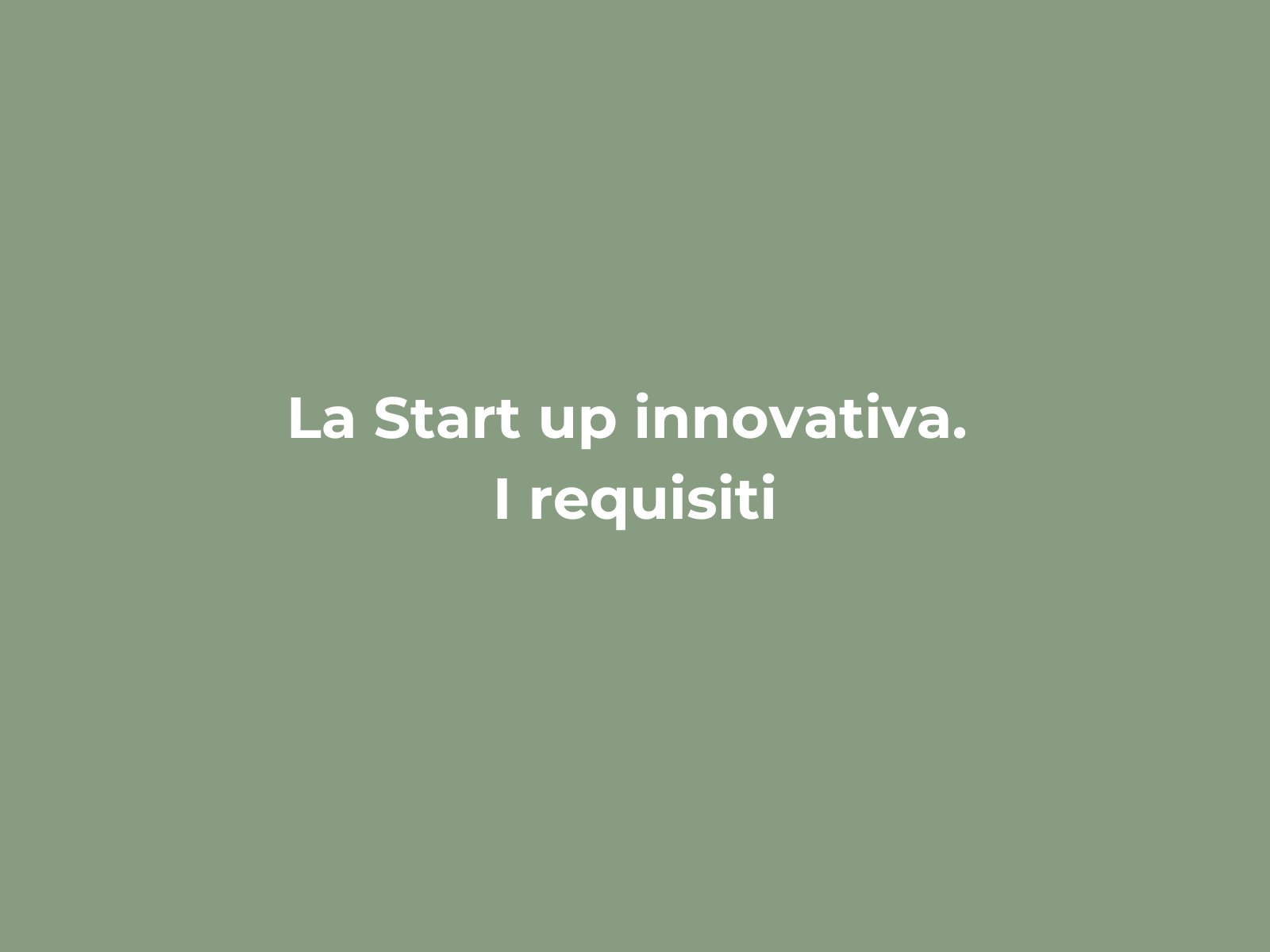Mi è capitato di dover intervenire su richiesta del Registro imprese competente al fine di rettificare l’atto costitutivo di una srl start up innovativa, regolamentata da uno statuto proprio di una srl ordinaria. E’ evidente, viceversa, che chi intende scegliere questa tipologia di società deve conoscerne accuratamente la disciplina1e la interpretazione che di detta disciplina fornisce la giurisprudenza, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti2.
Con l’espressione start-up si intende “un organizzazione temporanea, che ha lo scopo di cercare un business model scalabile e ripetibile”3. La start up normalmente passa attraverso varie fasi: quella iniziale di creazione del business, a cui segue la c.d. fase di “call”, ossia di ricerca dei primi investimenti e poi quella dell’execution, dove la società si gioca il tutto per tutto, mettendo a punto il prodotto e lanciandolo sul mercato. Infine la start up può passare da start up a scale up quando la società realizza un volume di fatturato tra i 50 mila e 100 mila euro mensili. Tuttavia non sempre la società accede alla fase della c.d. “scale up” preferendo cercare la c.d. “exit”, cioè la vendita della società ad un grosso gruppo industriale che possa ulteriormente finanziare “in grande” la società incentivandone la crescita esponenzialmente. Nel nostro paese l’exit sembra la strada preferita, scelta da molte start up, quali Facile.it, Mutui On Line e PizzaBo.
L’ordinamento italiano è uno dei primi tra quelli comunitari ed europei4 ad avere dedicato una serie di regole speciali specifiche per le start up innovative. La fattispecie start up innovativa è stata introdotta nel secondo “decreto crescita” (DL 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, modificato con il DL 28.6.2013 n. 76, convertito con modificazioni in legge 9.8.2013 n. 99 e dal DL 24.1.2015 n. 3, convertito in L. 24.3.2015 n. 33). Non è un tipo societario autonomo ma una “qualifica temporanea”, che può essere conferita a società di capitali di nuova costituzione o preesistenti, ma giovani, previa iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese ed in presenza di alcuni requisiti sostanziali. In altre parole il legislatore ha indicato una serie di possibili deroghe ai modelli societari, in particolare al modello srl, consentendo a quest’ultima, per un periodo di tempo limitato, di “vestire anche i panni della spa”, addirittura “rinnegando” l’ultimo requisito tipologico che la caratterizzava (il divieto di accedere al mercato del capitale di rischio) anche se come ripetiamo per un periodo limitato nel tempo.
L’esistenza di una mission innovativa dell’azienda trova nel DL 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221, una deroga “premiale” ad alcune regole: proprie del diritto societario, in particolare con riferimento al trattamento di eventuali perdite civilistiche, trattamento più leggero rispetto a quello riservato alle società non innovative5; proprie del diritto fallimentare, con riferimento all’esenzione dal fallimento.
L’art. 25 co. 2 del DL 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221, individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono avere le società per essere considerate start up innovative e fruire in tal modo del regime agevolativo delineato nella sezione IX del DL.
Sotto il profilo oggettivo:
è un’impresa nuova oppure costituita da non più di cinque anni. Ciò determina una evoluzione del concetto di start up non più legato ad imprese di nuova costituzione ma a una disciplina legale di nuova introduzione, tuttavia “compatibile” con imprese preesistenti “seminuove”;
a decorrere dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua, risultante da bilancio approvato non sia superiore a 5.000.000,00 euro. Infine, era (nella versione iniziale poi abrogata) richiesto che la maggioranza del capitale sociale e dei voti nell’assemblea ordinaria fosse (al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi) rappresentata da persone fisiche;
non è quotata in un mercato regolamentato oppure in una piattaforma multimediale di negoziazione;
non distribuisce gli utili ma li reinveste nella start-up stessa6
la forma societaria richiesta è quella delle società di capitali, anche in forma di cooperativa, di diritto italiano, o equivalenti comunitarie, che abbiano la residenza nel nostro Paese ai sensi e agli effetti dell’art. 73 del TUIR7;
l’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico8. La norma è stata modificata in sede di conversione in legge e non richiede più un oggetto innovativo “esclusivo” ma solo “prevalente”9, il che se da un lato amplia le possibilità per le società soprattutto già costituite di rientrare nella normativa di favore, attenuando i canoni richiesti per il riconoscimento dei requisiti di start up innovativa, dall’altro si presta ad abusi in materia di valutazione e interpretazione del concetto di prevalenza;
la start up innovativa, per espressa previsione normativa, non può derivare da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda10.
Oltre ai requisiti appena descritti il legislatore ne impone un ulteriore che può essere alternativamente individuato tra i seguenti, tutti sufficienti comunque per attestare la mission innovativa dell’impresa: le spese di ricerca e sviluppo, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato e descritte in nota integrativa, dovevano essere almeno uguali al 15% del maggior valore tra costi e valore totale della produzione di cui alle lettere A e B) dello schema di conto economico; almeno 1/3 del totale della forza lavorativa complessiva doveva essere rappresentato da personale in possesso di un dottorato di ricerca o che svolgeva il dottorato presso università sia italiane che straniere o comunque in possesso di una laurea e che abbia svolto, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati, in Italia o all’estero11; la società doveva essere titolare o depositaria12 o licenziataria di almeno una privativa relativa a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa13.
In riferimento all’ultimo inciso che mette in relazione il brevetto o la privativa industriale con l’effettiva attività svolta dalla società ha avuto modo di soffermarsi anche la Suprema Corte precisando che “è il caso di evidenziare come i requisiti prescelti dalla legge, ed in particolare quelli alternativi contemplati nella lettera h), testimoniano l’intento del legislatore di incentivare, agevolandola, solo la start-up che sia effettivamente, e non solo formalmente o statutariamente, munita di una reale capacità innovativa, correlata alla propria concreta attività (è significativo al riguardo, che la mera titolarità di un brevetto o di una privativa industriale non sia sufficiente se non direttamente collegata all’oggetto sociale e all’attività di impresa concretamente svolta)14.
Andando oltre, la impresa start up si caratterizza innanzitutto per la qualifica temporanea associata a uno specifico stadio di transizione, di durata massima quinquennale, corrispondente alle fasi di ricerca e di sviluppo dell’idea innovativa, di predisposizione dell’apparato aziendale e di avvio del ciclo produttivo.
La start- up innovativa, per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dalla legge, oltre ad essere in possesso dei predetti requisiti, deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, tenuto presso le Camere del Commercio, ex art. 2188 c.c. Sotto il profilo formale, il legale rappresentante della start-up innovativa, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, dovrà depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese un’autocertificazione attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti richiesti, procedendo poi all’automatica iscrizione, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.
Dopo aver ottenuto l’iscrizione, il legale rappresentante deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti mediante una dichiarazione ad hoc da depositare, di regola decorsi trenta giorni dall’approvazione del bilancio15, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio16. Il mancato deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti che comporta la cancellazione della start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese17, ferma restando l’iscrizione nella sezione ordinaria18.
Alle start-up innovative spettano alcuni trattamenti “premiali”, ossia una disciplina speciale di favore in tema di riduzione del capitale, ma soprattutto la normativa di favore in ambito di diritto fallimentare che sottrae la start up innovativa, per i primi 5 anni dalla costituzione, alle procedure concorsuali di cui al RD 267/42 (fallimento, concordato, liquidazione coatta), con assoggettamento, invece, al procedimento della crisi da sovra indebitamento di cui alla L. 27.1.2012 n. 3 e sue modifiche.
Pertanto, come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione “la disciplina agevolata cessa di avere applicazione non solo alla scadenza del quinquennio (o del diverso minor termine previsto dall’art. 25, comma, 3), ma anche quando, prima di quel termine, la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 819.
L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE START-UP INNOVATIVE E LA NECESSITA’ DI UNA LORO CONTINUA VERIFICA
Tra i requisiti richiesti per conseguire e mantenere la qualifica di start-up innovativa vi è quello che l’oggetto sociale e la conseguente attività siano rivolte, in via esclusiva o “prevalente”, allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Come anticipato nel paragrafo precedente l’iscrizione nella sezione speciale della start-up innovative, pur necessaria, è di per sé ritenuta insufficiente tutte le volte in cui ad essa non corrisponda l’effettivo e “attuale” possesso dei requisiti di legge ed un’attività di impresa che in concreto sia rivolta alla creazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi o ad alto contenuto tecnologico-scientifico20.
Tra i requisiti richiesti per conseguire e mantenere la qualifica di start-up innovativa vi è quello che l’oggetto sociale e la conseguente attività siano rivolte, in via esclusiva o “prevalente”, allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
E’ evidente, di conseguenza, che i presupposti per ottenere i benefici legati alla qualifica di start-up innovativa, legati alla descrizione dell’attività che si svolgerà contenuta nell’oggetto sociale, non sono puramente documentali21, ma implicano un giudizio anche di possibile prevalenza (dell’attività innovativa ad alto valore tecnologico rispetto ad altre attività non innovative pure svolte dalla società che, di conseguenza, dovrebbero essere non prevalenti). Ciò implica la verifica in concreto dell’attività effettivamente svolta anche attraverso i relativi dati di bilancio22.
Ulteriori requisiti richiesti sono la mancata distribuzione di utili, che sembrerebbe sottintendere la regola che eventuali profitti dell’impresa debbano essere necessariamente reinvestiti nella stessa iniziativa imprenditoriale e non andare a remunerare i soci, quantomeno nei primi 5 anni di costituzione e il limite quantitativo inerente al valore della produzione annua di cui all’art. 25, comma 2, lettera d. La norma prevede che a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve superare i 5 milioni di euro.
E’ evidente che il rispetto del requisito della mancata distribuzione di utili non può essere determinato e affidato all’esistenza di una clausola in statuto ma deve corrispondere ad un criterio di effettività in mancanza del quale gli stessi benefici legali (in particolare l’esenzione dal fallimento) apparirebbero ingiustificabili. Ugualmente il limite quantitativo inerente al valore della produzione annua richiede un effettivo riscontro contabile sull’attività effettivamente svolta e non semplicemente declamata ab initio in sede di iscrizione.
Infine, secondo l’art. 25, lett. h) del D.l. 179/2012 la start-up innovativa deve possedere almeno una delle seguenti ulteriori caratteristica: sostenimento di spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior dato relativo al costo o valore della produzione…; possesso di una forza lavoro che per almeno il 30% sul complessivo impiegato risulti in possesso di laura ed esperienza di ricerca specifica, ovvero dotato di dottorato o che sta svolgendo il dottorato di ricerca; la società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa relativa ad una invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, oppure deve risultare titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato e purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa23.
E’ evidente che anche i requisiti alternativi di cui alla lettera h), ossia “il riferimento alle spese di ricerca o innovazione, forza lavoro specificatamente formata o disponibilità di privative industriali va riscontrato nella pratica e nell’addentellato concreto rispetto all’attività di impresa così come di fatto realmente esercitata24.
Prova ne è che in giurisprudenza si è dichiarato il fallimento di una srl già iscritta nella sezione speciale come start-up motivando che la stessa aveva “sì presentato…domanda di brevetto…per invenzione industriale….ma l’ente competente (Ministero dello Sviluppo Economico) le ha risposto.. che il progetto presentato non possedeva le caratteristiche tipiche del brevetto industriale, bensì del modello di utilità…Con ciò escludendosi pertanto la ricorrenza del requisito di cui al n. 3, relativo alla sola privativa per invenzione industriale e non a quella per modelli di utilità, senza che a quest’ultima (di conseguenza) possa essere estesa la disciplina di esenzione dal fallimento di cui al combinato disposto degli artt. 25 e 31 D.l. 179/2012, essendo il ricorso all’analogia impedito dal carattere eccezionale, e quindi di stretta applicazione, di tale disciplina (art. 14 disp. Prel. c.c.)25.
IL CONCETTO DI INNOVAZIONE
Nella disciplina delle società start up innovative, oltre a qualificare il nomen iuris dell’istituto, l’innovazione compare tra i requisiti necessari cumulativi per la definizione della fattispecie. Nel co. 2 lett. f) dell’art. 25 del DL 179/2012 si precisa, infatti, che l’oggetto sociale (prevalente o esclusivo) deve consistere ne “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
Il concetto di innovazione non è delineato e definito nel testo normativo. Anzi come sottolineato dalla dottrina esso presenta, tra i requisiti richiesti, “il maggior grado di vaghezza26. È controverso, infatti, se la valutazione circa l’innovatività vada compiuta in senso formale (sull’oggetto sociale) o in senso sostanziale (sull’attività effettivamente svolta dalla società) o in entrambi i sensi, ma anche entro quali limiti l’attività possa essere qualificata come innovativa27. Il tutto si riverbera, ovviamente, sulla possibilità per il notaio di accertare la sussistenza dei requisiti in sede di costituzione28.
L’incertezza di cui sopra condiziona a cascata anche l’accertamento del secondo requisito obbligatorio da pescare tra tre opzioni alternative. Infatti, la società deve essere “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale…direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”.
Non solo, circa i rapporti di lavoro, le ragioni per la deroga alla disciplina dell’art. 5 co. 3 del DLgs. 368/2001 sussistono per i contratti a tempo determinato per “attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale”. Anche se il legislatore ci ha graziato non riferendosi generalmente anche alla competitività, suo grande “pallino”, non manca tuttavia di farvi riferimento quando tra le spese ricomprende anche quelle relative allo “sviluppo precompetitivo e competitivo”.
La fattispecie start up si connota per la compresenza di un indice diretto di innovatività, ossia che “l’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” e di un indice sintomatico della stessa (scelto fra tre: costi di R & S, coinvolgimento di personale specializzato, dotazione di privative industriali)29.
Dunque, l’oggetto sociale deve contenere due requisiti: “la novità e l’alto valore tecnologico30. Secondo una prima tesi la formula andrebbe intesa in modo estensivo, “sino a ricomprendervi le modalità di produzione, se innovative, degli stessi beni o servizi. In questo senso, un’impresa si ritiene innovativa qualora da essa derivino non solo nuovi prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, ma anche nuove metodologie e tecniche per produrli, usarli e distribuirli senza limitazioni di settore, aperta a tutto il mondo produttivo31. Pertanto, sarebbe necessario che l’impresa introduca “un elemento migliorativo sotto il profilo tecnologico rispetto allo stato dell’arte nel settore di riferimento32, ma ciò non implica che l’attività debba tradursi nella realizzazione di beni o servizi di nuovo genere33.
Per una seconda tesi si dovrebbe “interpretare il dato testuale in coerenza con una connotazione forte dell’indice di innovatività e dunque prendere come termine di riferimento lo stato delle conoscenze tecniche di pubblico dominio e non già il mero contesto dell’offerta (più o meno innovativa) sul mercato di prodotti o servizi: innovativa è l’impresa che accresce lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche; non quella che innovi semplicemente le modalità di approccio al mercato nell’offerta di prodotti o servizi già presenti34.
Riteniamo preferibile la prima delle due tesi, L’oggetto sociale contribuirà in maniera decisiva ad attirare verso il progetto innovativo nuovi investimenti nella società, investimenti che sono peraltro “premiati” dal legislatore, dando al socio interveniente la garanzia di poter facilmente azionare il recesso in presenza di una modifica, sia pure implicita, rispetto alla clausola dell’oggetto sociale, laddove un oggetto vago ed impreciso determinerebbe un annacquamento del diritto di recesso del socio.
L’oggetto sociale assume, infine, per le srl una rilevanza di non poco momento, in relazione alla rimborsabilità dei finanziamenti effettuati dal socio alla società. La norma dell’art. 2467 c.c., dispone, infatti, che il rimborso del finanziamento effettuato da un socio alla società è postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali quando il finanziamento è stato effettuato in un momento in cui, “in considerazione del tipo di attività svolta dalla società”, risulti uno squilibrio tra l’indebitamento ed il patrimonio netto.
Lo squilibrio è, però, tollerato, anzi quasi presunto, nella fase iniziale dell’attività sociale di una start up innovativa dalla normativa, per cui sarà da verificare se ciò sposti temporalmente in qualche maniera il concetto di “squilibrio”.
La normativa, nel riferirsi all’oggetto sociale parla di attività attinente “in via esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico35.
Tale enunciazione è necessario accompagni nella indicazione statutaria dell’oggetto sociale l’ulteriore indicazione specifica dell’attività svolta.
Difatti, la giurisprudenza ha ritenuto non rispondere ai requisiti per la classificazione della società come start-up innovativa (con conseguente assoggettamento a fallimento nonostante la formale iscrizione nella sezione speciale) l’oggetto sociale di una srl che prevedeva “la progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico”, dimenticandosi però di precisare “che i predetti prodotti e sevizi, oltre che ad essere di alto valore tecnologico, presentino altresì un carattere di innovatività. Carattere invece espressamente richiesto dalla lettera f) dell’art. 25, il quale, appunto, prevede che l’impresa, per essere qualificata start-up innovativa, debba avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in tal modo rendendo imprescindibile la concomitante presenza dei due distinti presupposti costituiti da un lato dall’elevato livello tecnologico del prodotto o del servizio e dall’altro della sua innovatività36.
L’art. 25 lettera f) indica tre attività, ossia sviluppo, produzione e commercializzazione, che la norma lega con la congiunzione “e”, situata tra sviluppo produzione da un lato e commercializzazione dall’altro.
Si potrebbe, di conseguenza, escludere che ad esempio la sola commercializzazione di prodotti innovativi consenta la qualificazione della società come innovativa.
All’opposto, il contesto generale della legge potrebbe forse applicarsi a società che si fermino alle prime due attività, ossia la ricerca e creazione di una privativa industriale, anche se la fase della commercializzazione venisse affidata a terzi.
Il legislatore non fornisce una definizione esatta di “prodotti o servizi ad alto valore tecnologico37. Una ricostruzione, forse un poco lassista, pone l’accento sul fatto che la lettera della norma parla di “valore” e non di “contenuto” tecnologico e ciò potrebbe, pertanto, legittimare una tesi che definisca innovativa anche l’attività finalizzata alla realizzazione di beni o servizi tradizionali, purché realizzati con nuove tecniche sofisticate e avanzate.
Tale lettura apre lo spazio ad una serie di attività come la creazione di dispositivi biomedici innovativi, la creazione di nuovi materiali o di nuove soluzioni nel campo delle biotecnologie, nelle nanotecnologie o nel settore delle Ict (information and communication technology), della bioedilizia e della c.d. “economia verde” (l’oggetto sociale potrebbe essere volto alla produzione e commercializzazione di soluzioni in grado di aumentare l’efficienza energetica, di abbattere i consumi di energia e di materie prime o di ridurre l’inquinamento)38.
Si è anche ipotizzato che tra le attività “a valore innovativo” possano orientare lo studio, la progettazione e la creazione di software ovvero la gestione in outsorcing di servizi informatici o la realizzazione di spin off accademici39.
Si è, infine, concluso che si potranno costituire anche società di ingegneria (di cui all’art. 90 co. 2 lett. b) del DLgs. 163/2006) per eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale40.
Si è ulteriormente scritto che non esistono limiti “a priori” per definire i campi di attività, potendo una start up innovativa operare anche in settori “tecnologicamente maturi”. Andrà presa in considerazione ogni tipo di attività economica da cui possano derivare nuovi prodotti/servizi, oltre che nuovi metodi per produrli, usarli e distribuirli41.
Sotto il profilo meramente teorico l’interpretazione sopra riportata potrebbe sembrare non condivisibile in quanto classificabile come “finto-innovativa”42, o, più benevolmente, “ancillare all’innovazione”, ma a tale tesi rigorista si potrebbe obiettare che la realtà con cui ci si deve confrontare è una realtà in cui i tempi di Leonardo da Vinci sono lontani e bisogna di conseguenza accontentarsi.
I DIVIETI PER LA START UP DI CUI ALL’AR. 25 SECONDO COMMA LETT. G) D.L. N. 179/2012
L’art. 25, secondo comma, D.l. n. 179/2012 elenca i requisiti che le società devono possedere ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e, tra questi, sub lett. g), (quale requisito negativo), viene richiesto che la società “non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda”.
La prassi dettata dagli enti governativi, agli albori dell’entrata in vigore della disciplina di settore, aveva inizialmente sottolineato la necessità di una lettura testuale delle disposizioni di divieto di cui agli artt. 25 e seguenti del D.l. n. 179/2012.
Tale formalismo legislativo, era stato esplicitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con la propria circolare prot. N. 164029/2013 con la quale si precisava che “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera43.
Sull’onda di tale primitiva lettura il MISE nel proprio parere n. 155183 del 3 settembre 2015 aveva sancito che nulla vieta che la start-up innovativa abbia origine da un affitto d’azienda, in quanto l’art. 2556 c.c. accomuna cessione e affitto in un’unica norma solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti, mentre sotto il profilo sostanziale la differenza tra le due fattispecie è comprovata dal fatto che l’art. 2562 c.c. rimanda alla disciplina dell’usufrutto d’azienda stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente animus e l’obbligo di restituzione finale44.
Tuttavia in tempi piuttosto veloci la suddetta posizione formalistica (tendente ad una interpretazione letterale tassativa e restrittiva dei divieti legali enunciati) ha ceduto il passo ad una interpretazione sistematica, improntata ad una maggior valorizzazione delle finalità che avevano ispirato la normativa del modello start-up innovativa. Tale inversione di tendenza sembra possa giustificarsi con l’avvento del nuovo modello speciale della P.M.I innovativa che, fatta eccezione per l’esenzione dal fallimento, consente anche a società preesistenti e datate di usufruire di diverse agevolazioni.
Tramite gli orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E/2014 e, a seguire, con il Parere del MISE prot. n. 68529/2020, al fine di evitare pratiche elusive, veniva, infatti, riconosciuta per la prima volta l’opportunità di una lettura estensiva dei divieti sanciti dal citato secondo comma lett. g) D.l. n. 179/2012.
In particolare il MISE con parere n. 68529 del 5 marzo 2020, in conformità alla tesi dottrinale45 e giurisprudenziale 46che equipara il conferimento di un’azienda in una società ad una cessione d’azienda, ha ritenuto che l’operazione di conferimento di azienda in società sia in contrasto con il divieto di cui all’art. 25, secondo comma, lett. G), sopra richiamato, divieto riguardante espressamente e letteralmente le sole operazioni di cessione di azienda o ramo di azienda.
La giurisprudenza di merito, preso atto dell’inversione di tendenza del MISE, materializzatasi nel parere prot. n. 68529/2020, facendo, peraltro espresso rimando a detto provvedimento, ha deciso che “in base alla medesima logica tendente ad agevolare l’avvio di nuove attività imprenditoriali a contenuto innovativo e a creare un volano per la crescita delle nuove attività, si ritiene che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo d’azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, debba essere inteso in generale, come divieto di costituzione di imprese agevolabili per effetto di un’operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento d’azienda o ramo d’azienda47.
La pronuncia detta, in maniera chiara e incontrovertibile, una chiave di lettura della normativa speciale di cui agli artt. 25 e ss. D.l. n. 179/2012.
Secondo il Tribunale meneghino, la ragione per cui il conferimento d’azienda deve essere, nel silenzio del legislatore, sanzionato alla stregua delle altre operazioni enunciate all’art. 25, secondo comma, lett. g) D.l. n. 179/2012 risiede, non solo e non tanto nella descritta similitudine di natura tra il negozio di conferimento e quello di cessione, ma principalmente nel fatto che, in termini più
generali ciascuno dei predetti istituti consente di realizzare una continuità con modelli imprenditoriali già in essere e, di conseguenza, “non nuovi”.
Il ricorso a tali schemi contrattuali confliggerebbe con la ratio della normativa speciale di settore che, al contrario, si sostanzia nella volontà del legislatore da un lato di incentivare la nuova imprenditorialità e, dall’altro, di impedire quelle operazioni elusive che di fatto costituiscono derivazione da realtà imprenditoriali preesistenti48.
Il Tribunale di Milano conclude affermando che “in ragione di tutti gli elementi evidenziati non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all’art. 31 D.l. 179/2012 secondo cui la start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3” e di conseguenza va affermata la fallibilità della società49.
L’art. 25, secondo comma, D.l. n. 179/2012 elenca i requisiti che le società devono possedere ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e, tra questi, sub lett. g), (quale requisito negativo), viene richiesto, come ampiamente già scritto, che la società “non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda”.
Il riportato dato normativo non menziona espressamente il negozio del conferimento d’azienda in società.
La giurisprudenza che si è interessata espressamente del problema con riferimento alle start-up innovative ha asserito che “è pacifica la piena assimilazione del conferimento di azienda alla cessione di azienda come disciplinata dall’art. 2560 s.s. (cfr. Cass. N. 18143/19). Per effetto della cessione sopra indicata la società .. diventava titolare dell’azienda già di titolarità di …organizzata per il commercio di prodotti innovativi e di alto valore tecnologico50.
L’assunto del Tribunale meneghino è, in effetti, pienamente in linea, sotto il profilo sistematico, con l’orientamento della giurisprudenza51 e della dottrina52 che equipara il conferimento di azienda alla cessione, ritenendolo soggetto alla disciplina contenuta negli artt. 2556 c.c., in ragione del medesimo oggetto del contratto traslativo, funzionale ad assicurare continuità all’impresa.
Di conseguenza il Tribunale di Milano ha ritenuto che il conferimento di un’azienda preesistente e dotata di un contenuto innovativo preesistente in una società priva di ogni innovatività costituisce operazione che cozza contro il divieto di cui alla lettera g) dell’art. 25, comma 2, D.l. n. 179 del 2012 che prevede che la società non sia costituita tramite cessione di azienda o ramo d’azienda.
Nella sentenza si è motivato che “lo schema contrattuale utilizzato dalla (società) per acquisire i requisiti di innovatività è in evidente contrasto con la ratio della norma sopra indicata che è quella di impedire attraverso trasferimenti in favore di newco lo svecchiamento di realtà imprenditoriali preesistenti consentendo a queste di rientrare nella definizione fornita dal comma secondo dell’art. 25 sopra richiamato. La norma mira dunque ad evitare che attraverso lo strumento normativo si favoriscano iniziative imprenditoriali costituenti derivazioni di realtà preesistenti, avendo invece l’intervento normativo il dichiarato fine di favorire la nuova imprenditorialità53.
Alla luce di quanto recentemente emerso in giurisprudenza (e appena riportato), che lo scrivente condivide, e preso atto dei più recenti orientamenti del MISE sono da riverificare i presupposti di alcuni vecchi precedenti pronunciamenti emanati dal MISE stesso.
Con il parere 155183 del 3 settembre 201554 il MISE ha affermato che l’art. 25, comma 2 lettera g) va inteso in senso letterale e quindi non è estensibile a tipi negoziali diversi da quelli che elenca, per cui l’affitto d’azienda non preclude a una società di iscriversi come start-up innovativa, posto che il relativo contratto è un tipo negoziale ben distinto dal caso della cessione di azienda o di un ramo di azienda.
Il Mise scrive che all’affitto si applicano le norme sull’usufrutto d’azienda, stante la provvisorietà dell’utilizzo dell’azienda che derivano tanto dal contratto di affitto quanto da quello con cui si concede l’usufrutto dell’azienda: entrambe fattispecie nelle quali viene semplicemente trasferito il godimento dell’azienda con obbligo della sua restituzione al termine del periodo di efficacia del contratto, oltre agli obblighi ricorrenti. In tali ipotesi non si applicano, invece, le norme proprie della cessione d’azienda, le quali presuppongono non la concessione del godimento, ma il trasferimento della titolarità dell’azienda che ne è oggetto.
In conclusione per il MISE nulla vieta che la start-up innovativa abbia origine da un affitto d’azienda, in quanto l’art. 2556 c.c. accomuna cessione e affitto in un’unica norma solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti, mentre sotto il profilo sostanziale la differenza tra le due fattispecie è comprovata dal fatto che l’art. 2562 c.c. rimanda alla disciplina dell’usufrutto d’azienda stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente animus e l’obbligo di restituzione finale.
Incomprensibilmente, però, in detto parere il MISE dà, comunque, conto che la ragione dei divieti di cui all’art. 25 secondo comma lett. g) Dl. 179/2012 va individuata nella volontà del legislatore di evitare che si origino start-up innovative frutto di spin-off di precedenti esperienze consolidate.
Tale conclusione lascia francamente perplessi e non pare allo scrivente condivisibile.
Infatti, l’unica via per evitare abusi della disciplina di favore sembra essere quella di inibire l’accesso al regime giuridico delle start-up a tutte quelle società che, di fatto, costituiscono un mero subentro nella titolarità di un compendio produttivo preesistente, a prescindere da ogni valutazione sulla natura dell’atto di disposizione determinante il passaggio del diritto di utilizzo (quindi compresi affitto e usufrutto d’azienda)55.
Dubbi di non minor portata sembrano sollevarsi dalla lettura del parere del MISE n. 6057 del 19 gennaio 2015 riguardante sempre un conferimento di azienda gestita come impresa individuale in una newco s.r.l. unipersonale di cui il proprietario dell’azienda, gestita come ditta individuale, diviene unico socio, operazione ritenuta dal MISE ammissibile.
Con grande estrosità il MISE ha affermato che “il conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale) sia unico socio, contempla, per le finalità di cui all’art. 25, comma 2, lett. g) del D.l. 179/2012, un’ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa – non è stata costituita…a seguito di cessione di azienda” di cui alla lettera g) predetta56.
In realtà, nello stesso parere l’ente afferma nell’ordine: che “la trasformazione atipica di impresa individuale in società di capitali, non è contemplata dal codice civile, che pure ha ampiamente disciplinato con la riforma, aumentandone il novero, le ipotesi di trasformazione omogenea ed eterogenea57; che i soggetti imprenditori individuali, pure titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’art. 25 e sss., in quanto non costituiti in forma societaria.
In forza delle sue stesse premesse anche detto parere non sembra condivisibile perché non si può a proprio piacimento inventare qualificazioni giuridiche non presenti nel nostro sistema (la c.d. trasformazione atipica di impresa individuale in società di capitali58, né ci si può sostituire al legislatore per ricomprendere nella sua normativa categoria di soggetti (nel caso di specie ditte individuali) che ne sono escluse, anche se tale esclusione sembra iniqua.
I due provvedimenti, sopra criticati, resi entrambi nel 2015 sembrano, peraltro, dettati in un momento storico in cui non vi era alternativa al modello start up innovativa è sembrava quindi opportuno, se non doveroso, allargare in parte le maglie della rete disciplinare delle start up innovative per includervi realtà similari, necessità venuta meno con l’introduzione del modello delle PMI innovative (nel 2015) con relativa sezione speciale a cui si possono iscrivere società “innovative” che operano per il tramite di una azienda già esistente e avviata59.