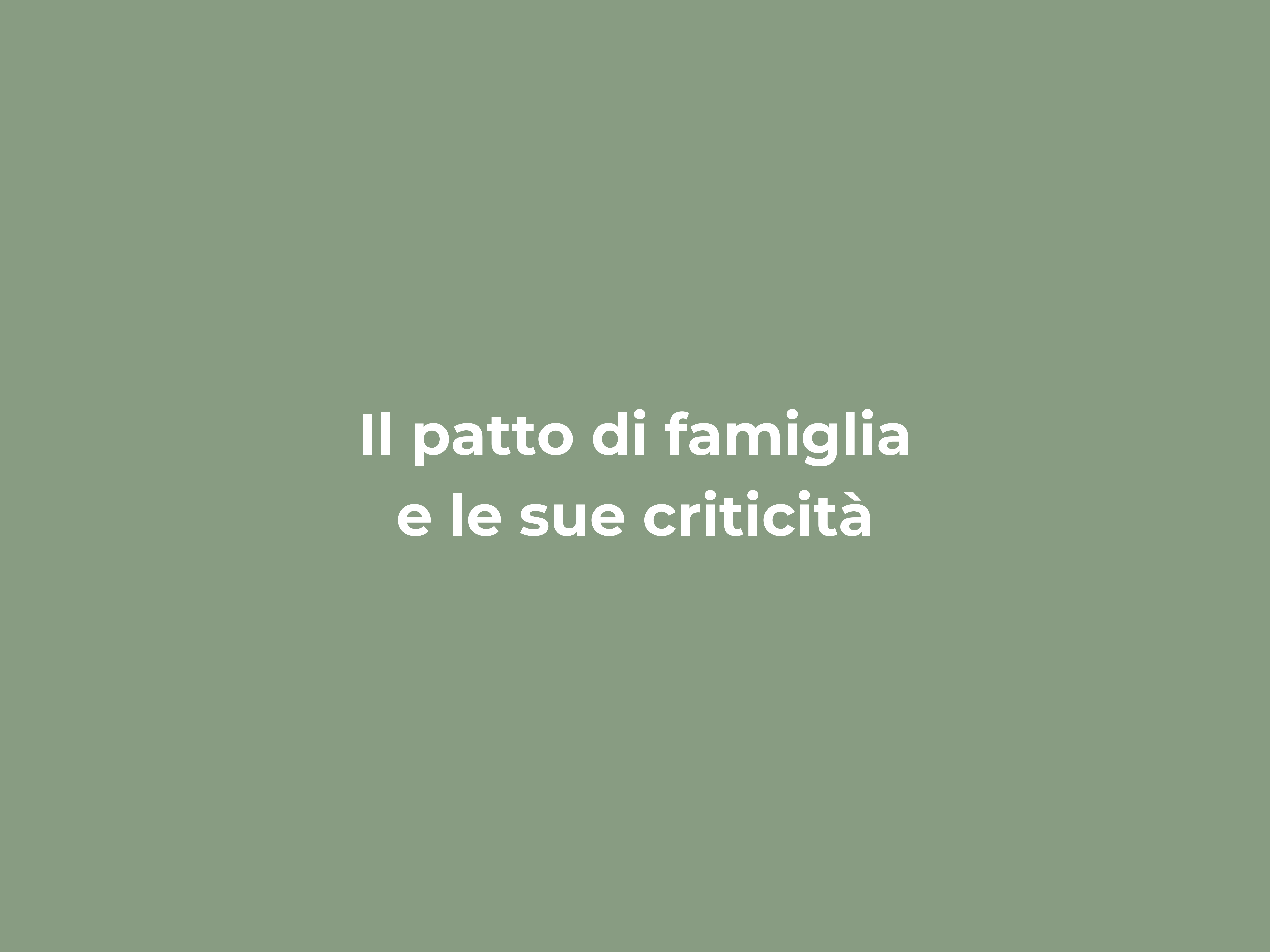L’istituto del patto di famiglia irrompe nel nostro ordinamento con la L. 14.2.2006 n. 55, che trova la sua origine nella Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994 (94/1069/CEE) sulla successione delle piccole e medie imprese, volta a favorire il passaggio generazionale nell’ambito delle imprese di tipo familiare, attraverso l’attenuazione del divieto dei patti successori e la trasformazione della riserva calcolata in natura in riserva calcolata in valore. Il patto di famiglia 26 avrebbe dovuto spazzare via ogni problema 27, ma in realtà così non è stato.
I profili di criticità sono molteplici. Innanzitutto, la legge, anche per interpretazione pacifica, pretende la partecipazione al contratto di tutti coloro che sono legittimari del titolare dell’azienda o delle partecipazioni sociali alla data della stipula. Dunque, è necessario un contesto familiare pacifico.
È, inoltre, ricorrente il problema dell’obbligato alla liquidazione dei legittimari diversi dall’assegnatario 28. Per legge obbligato è quest’ultimo, ma in tal caso, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione 19.12.2018 n. 32823, “il patto di famiglia di cui agli artt. 768 c.c. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione del disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di essenzialità
di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario” 29.
Non erra, pertanto, chi sostiene che il patto di famiglia sia stato “azzoppato” dalla Cassazione 30, o che comunque il patto di famiglia “inciampa sul fisco” 31. Infatti, il patto di famiglia è assoggettato, secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, a una doppia tassazione: la prima a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con aliquota del 4% oltre 1 milione di euro; la seconda a favore dei fratelli e delle sorelle, con aliquota del 6% oltre 100.000 euro 32.
La Suprema Corte è precipitosamente ritornata sui propri passi con una successiva ordinanza del 24.12.2020 n. 29506 33, con la quale fa affermato che nel patto di famiglia sussiste senza dubbio la causa di liberalità, ma ad essa si affianca, senza snaturarla, l’adempimento di un obbligo, imposto dalla legge, scaturente dalla necessità di liquidare i legittimari.
Dal punto di vista degli effetti, la presenza di tale obbligo, si sostanzia in un peso gravante sull’attribuzione operata con il patto di famiglia, in tutto simile a quanto accade con il compimento di una liberalità gravata da un onere (v. per la donazione modale l’art. 793 c.c.). Tuttavia, nel patto di famiglia l’onere non ha fonte negoziale, ma legale, e non costituisce un elemento accidentale dell’attribuzione, ma un elemento necessario. Ne consegue che alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali è applicabile l’art. 58 comma 1 del DLgs. 346/90, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio (in parole povere una sorta di donazione fiscalmente posta in essere sempre e comunque dal disponente) 34.
Va altresì segnalato, per completezza argomentativa, che solitamente l’assegnatario è privo dei mezzi necessari per operare la liquidazione di tutti i legittimari; nella prassi, tale onere è adempiuto dal disponente imprenditore, con la tecnica dell’adempimento del terzo, a titolo di liberalità indiretta a favore dell’assegnatario, che guadagna la liberazione dall’obbligo di liquidare gli altri legittimari. Di qui il dibattito dottrinale in ordine all’esenzione da riduzione e collazione anche delle liberalità comprese nel patto diverse dalle partecipazioni sociali. Quando è il disponente che provvede anche alla liquidazione dei legittimari in luogo del beneficiario realizzando un patto di famiglia atipico c.d. “verticale” non è del tutto certo che vi sia piena assimilazione con la fattispecie delineata dal legislatore ove è il beneficiario a tacitare i legittimari (c.d. patto di famiglia orizzontale) 35.
Debole è anche la possibilità di avvalersi effettivamente del recesso, e quindi del diritto di ripensamento, per una precisa ragione: vi è infatti stato un esborso economico compensativo a favore degli altri legittimari. Dovendo sopportare un sacrificio economico, l’assegnatario non accetta solitamente l’inserzione di simile clausola nel patto di famiglia. Ne consegue, per quanto scritto, che il patto di famiglia comporta il trasferimento definitivo della proprietà della società all’assegnatario che spesso si impegna a saldare i legittimari a rate o comunque con modalità dilazionate e ciò senza che si possa più intervenire sul compendio aziendale di fronte a sventure patrimoniali dell’assegnatario.
Infine, secondo Cassazione 36, il requisito della trasmissione del controllo, di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, non ricorre (e, pertanto, non compete l’esenzione da imposta di donazione disposta dalla normativa predetta) nel caso in cui, mediante patto di famiglia, sia trasferito dal disponente a favore di tre figli un pacchetto azionario, ognuno di entità pari al 24,5% del capitale sociale, qualora i figli siano stati vincolati in un patto parasociale di blocco e di voto stipulato successivamente alla stipula del patto di famiglia 37.
Conclusivamente, in merito al patto di famiglia, la dottrina ha ritenuto che frequentemente tale istituto non sia soddisfacente dal punto di vista patrimoniale, in quanto presuppone la liquidazione dei discendenti non assegnatari dell’azienda con la sola quota di legittima, dunque con un valore inferiore rispetto a quello attribuito agli assegnatari 38.
È, invece, frequente che il capo famiglia, pur volendo attribuire le responsabilità gestorie solo ad uno o al massimo ad alcuni discendenti, non intenda in alcun modo fare differenze tra i suoi figli nelle attribuzioni patrimoniali. Quindi il fondatore normalmente vuole adottare nella ripartizione dell’azienda principi differenti, trasferendo la direzione operativa sulla base del “principio del merito” e quindi al discendente con le maggiori capacità imprenditoriale, mentre quando si tratta di trasferire la proprietà, invece, le capacità imprenditoriali dei discendenti sono molto meno rilevanti, prevalendo nettamente il “principio dell’equità”.
Creando categorie di quote (come si vedrà) è oggi possibile rispettare sia il principio dell’equità sia il principio del merito nel trasferimento della società familiare.