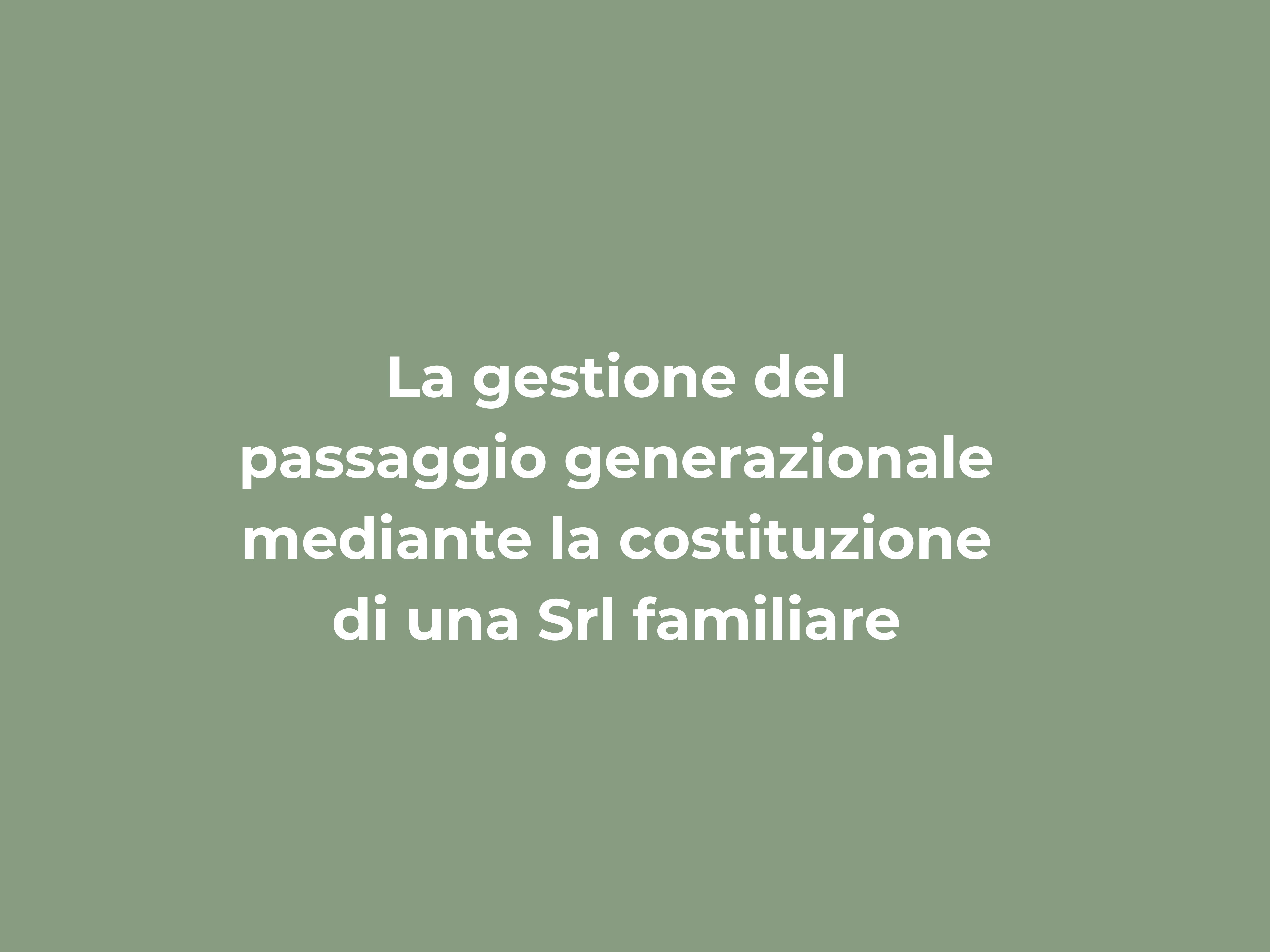Alcuni dei rilevanti problemi che si pongono nel passaggio generazione dell’impresa potrebbero trovare soluzione attraverso la costituzione di una srl PMI. In questa forma societaria, ad esempio, attraverso specifiche clausole statutarie, il capofamiglia potrebbe conservare la piena facoltà di amministrare, ma al contempo assegnare ai propri familiari, attraverso le categorie di quote con diritti speciali, particolari diritti in tema di distribuzione degli utili, oppure difendere i figli meno capaci, in caso di vendita della maggioranza o di aumenti di capitale sociale.
1 – Le srl familiari prima della introduzione della normativa della srl PMI
Uno dei modelli di srl maggiormente diffusi in Italia è quello in cui soci siano componenti della medesima famiglia1, spesso costituita in seguito all’evoluzione dell’impresa individuale creata dal capo famiglia che, nel tempo, ha voluto condividere con il coniuge e i propri discendenti i risultati economici della sua attività2. In dette società sono sempre esistite di fatto due categorie di soci, anche se non enunciate: i soci imprenditori (il capo famiglia e/o uno o più dei suoi discendenti), interessati alla gestione della società oltre che a conseguire l’utile, e i soci di capitale (gli altri familiari), estranei alla gestione ma interessati ai dividendi3. La circostanza che in Italia fosse perlomeno dubbio che i singoli diritti a cui erano interessati i diversi soci si potessero caratterizzare in specifiche categorie di quote (e soprattutto si potesse escludere il diritto di voto) aveva portato a soluzioni empiriche più prudenti, nel tentativo di attribuire, quanto meno di fatto, a ciascun socio le prerogative che gli dovevano essere proprie4. Nella prassi le soluzioni più comunemente adottate sono state le seguenti:
– l’elevazione delle maggioranze decisionali, al fine di rendere determinante il voto dei soci imprenditori. Tale soluzione, tuttavia, ha consentito ai soci imprenditori di godere di un diritto di veto sulle decisioni5, ma non un vero diritto decisionale, esponendo la società al rischio dello stallo decisionale 6
– la riserva per statuto ai soci imprenditori del diritto di amministrare nella forma del diritto particolare dei soci. Tale opzione consente ai soci imprenditori di mantenere il controllo della gestione7, ma non il controllo sulle decisioni dei soci ed in particolare sulla decisione di approvazione del bilancio che assegna agli altri soci un potente strumento di opposizione;
– la previsione di clausole di prelazione gradimento nel caso di vendita a soggetti estranei al nucleo familiare8. Tuttavia, dette clausole hanno il limite di imporre ai soci che non intendono acconsentire al trasferimento delle partecipazioni di liquidare gli altri soci.
2 – Srl PMI familiare: opzioni nelle categorie speciali di quote
Le srl PMI familiari possono avvalersi della facoltà di emettere quote di categoria pur senza offrirle agli investitori, al solo scopo di assegnarle ai componenti di determinati nuclei familiari9.
In questo modo si realizzerebbe un meccanismo particolarmente congeniale all’organizzazione delle società familiari, dato che l’istituto permette di attribuire ai soci posizioni differenziate, in grado di essere tramandate ai successori mediante il trasferimento delle partecipazioni10. È quindi possibile articolare la compagine sociale in gruppi omogenei, tendenzialmente costituiti dagli esponenti dei singoli rami familiari, attraverso l’attribuzione di specifiche categorie di quote11.
La dottrina ritiene che nelle srl PMI familiari, anche qualora la società non ricorra al mercato del capitale di rischio, sia possibile creare quote ordinarie da attribuire ai soci imprenditori e quote di categoria, prive del diritto di voto e eventualmente dotate di tutti gli altri diritti, da attribuire ai soci familiari. In tal modo si definiscono i reali diritti attribuiti a ciascun socio, senza artifizi o compromessi, ottenendo la certezza e la stabilità degli equilibri12. Inoltre, nel caso di successiva cessione delle quote di categoria, si attenua enormemente l’interesse dei soci imprenditori a negare il gradimento o ad esercitare la prelazione con obbligo di liquidare i soci che intendono alienare le loro partecipazioni, visto che le limitazioni di diritti portate dalle quote di categoria rendono di fatto indifferente ai soci ordinari chi siano i titolari delle quote prive del diritto di voto.
Non solo, sotto il profilo operativo, creando in anticipo le categorie di quote, quando ancora la società appartenga al capo famiglia (che le sottoscriverà tutte nell’esercizio legittimo del proprio diritto di sottoscrizione), sarà possibile per il fondatore gestire il passaggio generazionale con una semplice disposizione testamentaria, o gradualmente nel tempo, attribuendo a ciascun figlio le quote di categoria che riterrà opportune. Nel caso concreto sarà poi possibile caratterizzare ulteriormente le varie categorie di quote attribuite ai discendenti al fine di assecondare esigenze o aspettative specifiche. Ad esempio: si potrà attribuire il diritto di recesso ai titolari delle quote senza voto nel caso in cui la società non raggiunga determinati risultati economici (slegandoli così dall’obbligo di condividere il risultato della gestione altrui); si potrà prevedere una maggiorazione nella distribuzione degli utili per i soci gestori, superando così quel senso di ingiustizia latente che viene spesso percepito dai discendenti che gestiscono l’impresa quando devono dividere in parti uguali con i fratelli i risultati del loro impegno13. Si potranno prevedere limiti alla circolazione solo per le quote senza voto, favorendo così il consolidamento nel tempo nei soli soci gestori delle intere partecipazioni. Si potrà, come consuetudine nella prassi, attribuire alle quote prive del voto il diritto alla distribuzione degli utili senza necessità di una delibera in tal senso dei soci ordinari, così evitando conflitti di interessi tra soci gestori e soci di capitale. Sotto il profilo fiscale, l’attribuzione del diritto di voto solo ad una categoria di quote, anche se minoritaria rispetto al capitale complessivo, consentirà lo sfruttamento dell’agevolazione fiscale prevista dal comma 4-ter dell’art. 3 del DLgs. 346/90 (Testo unico successioni e donazioni) nel caso di donazione delle quote dal genitore ai figli14 nell’ipotesi in cui al discendente designato, nel proseguire la gestione della società, sia attribuita una partecipazione che rappresenti una minoranza del patrimonio sociale, come spesso è necessario fare in presenza di più figli15. Infatti, detto socio avrà comunque tecnicamente il controllo della società16.
Sul piano dei diritti amministrativi è significativa la facoltà di escludere in radice il diritto di voto o la sua attribuzione in senso non proporzionale17. Quanto alle posizioni a rilievo patrimoniale, l’assenza di limiti temporali alla distribuzione degli utili rende l’istituto congeniale all’organizzazione delle imprese a costituzione familiare, in quanto permette di modulare il contenuto delle categorie di quote assegnate ai componenti di singoli nuclei familiari in considerazione del loro diverso interesse alla remunerazione del capitale18.
3 – Srl PMI familiare: opzioni rinvenibili nelle esperienze straniere per controbilanciare il potere di voto dei soci manager
Nel caso di categorie di quote che attribuiscono ad un determinato ramo familiare o ad alcuni familiari eletti il diritto di governare la società, normalmente, nell’esperienza (soprattutto anglosassone) si consiglia l’introduzione di una serie di clausole che in qualche modo controbilancino lo strapotere dei familiari prescelti nella direzione dell’impresa al fine di evitare una loro gestione troppo sbilanciata in favore dei loro interessi personali19.
Una prima clausola normalmente negoziata in favore della classe di quotisti rappresentanti i familiari soci non interessati e/o non coinvolti nella gestione della società è quella della c.d. “board rappresentation”20, che riconosce ai soci familiari di mero capitale il diritto di natura amministrativa di nominare e revocare parte dei componenti dell’organo amministrativo: immaginando un CdA composto di cinque membri, si potrà avere un board nel quale la categoria di quote dei familiari fondatori o managers nominerà tre amministratori tra i quali per clausola statutaria dovrà essere scelto l’amministratore delegato, mentre gli altri due (spesso con spettanza della elezione a presidente) verranno nominati dalla categoria di quote dei familiari soci di mero capitale21. Normalmente per previsione statutaria agli amministratori designati dai soci di mero capitale non spettano né deleghe operative né particolari emolumenti. Le tecniche relative al voto (voto di lista ecc.) consentono di realizzare la volontà negoziale di cui sopra.
I soci familiari di mero capitale, spesso privati del diritto di voto, sono interessati ad avere un diritto di veto (c.d. “veto right”) 22su determinate delibere riguardanti operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, emissioni di nuove classi di quote o modifiche di diritti sulle categorie di quote, piani di stock options, acquisto di quote proprie, distribuzioni di dividendi o riserve. A detti argomenti si aggiungono anche eventuali diritti di veto su operazioni di gestione che i soci si siano riservati statutariamente ex art. 2479 c.c. come, ad esempio, l’assunzione o modifica di finanziamenti di importo superiore a una certa cifra o acquisto o cessione di partecipazioni sociali o di aziende. Detti diritti, definiti “restrictive convenants”, assegnando a una determinata categoria di soci un diritto di veto, ridisegnano e limitano la libertà di azione dell’organo amministrativo e possono comunque ingenerare nella categoria di soci “vietanti” anche un eventuale responsabilità ex art. 2476 comma 7 c.c.23. I soci familiari di mero capitale negoziano spesso anche un ulteriore diritto di natura amministrativa, ossia quello di avere un’informativa periodica relativa all’andamento economico, finanziario e di business della società, con rendicontazioni addirittura mensili per quanto riguarda il rendiconto finanziario e trimestrali per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale.
Recentemente a detti documenti se ne è aggiunto nella prassi un ulteriore, ossia il rapporto che sintetizza il business delle attività di sviluppo. Normalmente a detta implementazione del generico diritto di informazione si accompagna l’esclusione del pervasivo diritto di ispezione e controllo di cui all’art. 2476 comma 2 c.c., sostituito da un più indiretto controllo sulla gestione affidato a un organo sindacale.
Ulteriore diritto che viene negoziato è quello di cedere le proprie partecipazioni nell’eventualità che il socio familiare manager ceda la propria partecipazione di controllo, c.d. “clausola di tag along24. Detta clausola che la CONSOB ha previsto debba obbligatoriamente essere inserita a tutela del socio investitore nell’ipotesi di collocazione della quota presso il pubblico dei finanziatori (mediante crowdfunding), è altrettanto necessaria in favore dei soci familiari depotenziati nel loro diritto di voice con l’esclusione spesso quasi totale del diritto di voto. Tale clausola sovente si accompagna a quella che vieta ai soci familiari con poteri di gestione di cedere le partecipazioni per un arco di tempo che normalmente oscilla tra 2 e 5 anni dal momento in cui il socio fondatore ha passato la mano all’erede designato.
Una clausola spesso contrattata è quella “anti-dilution”, ovvero quella clausola che consente al familiare non coinvolto nell’attività di impresa di non veder diluita la propria partecipazione25 nel caso in cui vi sia un aumento del capitale con ingresso di nuovo/i socio/i. Tale clausola va predisposta con attenzione al fine di evitare di incappare nel divieto del patto leonino. Infatti, per parte della giurisprudenza la clausola anti-diluizione non sarebbe ammissibile nei casi di aumento finalizzato alla ricostituzione del capitale interamente perso e con perdite superiori allo stesso capitale26
Un socio familiare non gestore particolarmente oculato e forte nella contrattazione potrebbe anche garantirsi la presenza di una clausola di “liquidation preference”. Tale clausola consente al familiare di garantirsi un certo ritorno patrimoniale nel caso di operazioni straordinarie, quali potrebbero essere la cessione di un pacchetto di controllo della società, la cessione dell’azienda o la liquidazione/scioglimento della società.
In tal modo il familiare non amministratore potrebbe, perlomeno, salvaguardare il valore che la sua partecipazione aveva nel momento in cui è stato estromesso o escluso dalla gestione e dall’esercizio del diritto di voice a beneficio del socio erede designato a gestire l’impresa familiare, gravando lo stesso della perdita generata dalla sua gestione27.
4 – Srl PMI: speciali categorie di quote
Come già scritto in altra sede 28 l’atto costitutivo della srl PMI, anche in deroga all’art. 2479 comma 5 c.c., può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
È evidente che la “categoria di quote”, insieme al meccanismo di crowdfunding evidenziano la volontà di creare una categoria di soci che non sono particolarmente interessati ad essere coinvolti nella vita e nella gestione societaria, ma che puntano invece sulla remunerazione del proprio capitale.
Lo scambio da proporre a detti soci è pertanto “sacrificale” per quanto riguarda il coinvolgimento del socio nelle decisioni e nella gestione della società e normalmente premiale nel rapporto patrimoniale ed eventualmente solo ed esclusivamente nelle relative decisioni.
Non si vuole né si potrebbe in questa sede approfondire tutte le possibilità inerenti al voto (ad es., tetto massimo di voto, voto scalare, voto scaglionato, voto capitario ecc.)29 che potrebbero caratterizzare le categorie di quote ma sembra opportuna una breve rassegna:
– tetto massimo, ad esempio, uno stesso soggetto potrà esprimere fino al 10% del capitale un solo voto; oltre nulla;
– voto scaglionato in relazione alla quantità delle quote possedute o alla percentuale di capitale detenuta da uno stesso soggetto30
– voto scalare: si pensi alla clausola statutaria che tolga il voto a pacchetti di quote superiori a una certa soglia (ad es., il 10%,
cosicché le quote eccedenti tale soglia non votino) oppure che lo diminuisca progressivamente (ad es.: 10% del capitale = 10 voti; 20% del capitale=18 voti; 30% del capitale=24 voti ecc.). La dottrina ha individuato la differenza tra voto scalare e voto plurimo nel fatto che nel primo caso la sospensione del voto generata dal raggiungimento delle soglie previste dallo statuto è possibile in quanto si tratterebbe di una modalità di esercizio del voto “che non attiene al contenuto dell’azione, ma si riferisce esclusivamente alla posizione soggettiva dell’azionista”31.
Per altra tesi, la differenza rilevante è stata rintracciata nella mobilità che contraddistingue il voto scalare, e cioè nel fatto che la limitazione del diritto di voto è legata al numero delle azioni possedute in un determinato momento e dunque ne segue le sorti consentendone sia una compressione che una riestensione in conseguenza delle soglie previste dallo statuto32
– è consentita anche una clausola c.d. mista, che combina, cioè, gli elementi del voto scalare e del tetto massimo, prevedendo uno scaglionamento del voto, che viene depotenziato fino ad una certa percentuale di possesso, per essere, infine, sterilizzato quando il possesso supera una certa quantità;
– voto capitario: quest’ultimo, normalmente caratterizzato da un numero contenuto di soci, sul piano fattuale si avvicina ad una clausola di mera rideterminazione quantitativa del diritto di voto. In forza di una simile previsione statutaria ciascun socio potrà esercitare un unico voto, a prescindere dalla quota di capitale posseduta;
– altra ipotesi è l’attribuzione alla quota del voto intermittente, caratterizzato dal fatto che il diritto di voto spetta solo al raggiungimento di un determinato importo di fatturato, di utile o di patrimonio netto, o nel caso di perdita del capitale; in questo caso il socio avrà diritto di voto a intermittenza, ossia tutte quelle volte che detto importo sarà raggiunto; si parla anche di c.d. clausole di rinascita o di clausole risolutive del voto, che condizionano la possibilità di esercitare il diritto di voto ovvero ne impediscono l’uso al ricorrere di determinati eventi. Le clausole possono essere costruite in modo tale da riproporre la sospensione del voto o la riallocazione del voto una volta verificatosi l’evento ed esercitato il diritto, oppure possono determinare anche definitivamente il venir meno del particolare contenuto della categoria, causando la conversione della partecipazione in ordinaria ovvero modificando i termini della categoria da partecipazioni con diritto di voto condizionato a partecipazioni prive del diritto di voto;
– si è già anticipato in altra occasione33 che, ad avviso di chi scrive, nelle srl è possibile dare vita alla nuova categoria delle quote “a voto plurimo” le quali consentono di esprimere un numero di voti maggiori di uno anche in multipli superiori al limite di tre (limite valevole per le sole spa chiuse);
– altro discorso vale per le quote a voto maggiorato pensate come strumento per stimolare il mantenimento di investimenti a lungo termine e, dunque, la presenza di soci durevoli34. Dal punto di vista operativo è opportuno precisare che le quote a voto maggiorato fidelizzanti (c.d. loyalty shares), a differenza di quelle a voto plurimo, che vanno a comporre una speciale categoria di partecipazioni, non rappresentano una nuova categoria di quote, ma un diritto attribuito al singolo socio e quindi spetta, con parità di trattamento, a tutti i soci che la meritano, in conseguenza della loro protratta permanenza nel capitale sociale.
5- Diritti speciali attribuibili alle categorie di quote: i diritti di veto
I soci di mero capitale, spesso ma non sempre privati del diritto di voto integralmente, sono interessati, come detto, ad avere un diritto di veto (veto right)35 su determinate delibere riguardanti operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, emissioni di nuove classi di quote o modificazione di diritti sulle categorie di quote, piani di stock options, acquisto di quote proprie, distribuzioni di dividendi o riserve36.
Alle materie di cui sopra si aggiungono anche eventuali diritti di veto su operazioni di gestione che i soci si siano riservati statutariamente ex art. 2479 c.c., normalmente non ricomprese nel budget o nel business plan concordato con gli investitori come ad esempio: l’assunzione o modifica di finanziamenti di importo superiore a una certa cifra o l’acquisto o cessione di partecipazioni sociali o di aziende, o le operazioni riguardanti la proprietà intellettuale della società, o la definizione di piani incentivanti in favore di collaboratori e/o dipendenti, o l’assunzione ed il licenziamento di personale dirigente, o operazioni con parti correlate.
Detti diritti definiti “restrictive convenants”, assegnando a una determinata categoria di soci un diritto di veto, ridisegnano e limitano la libertà di azione della società e del suo organo amministrativo37 e possono ingenerare nella categoria di soci “vietanti” anche un eventuale responsabilità ex art. 2476 comma 7 c.c. Oltre ad un diritto di veto costituente un c.d. restrictive convenants è possibile assegnare ai soci di categoria speciale diritti di voto o diritti di approvazione (c.d. protective provisions), ovvero prevedere che certi atti possano essere adottati solo con il consenso dei soci privilegiati38.
I voti necessari possono essere espressi separatamente nell’assemblea speciale (c.d. voting as a class) o nell’assemblea generale della società insieme con i soci ordinari (c.d. common shareholders) e cioè on an as converted basis.
Il voto per classe in assemblea speciale permette ad una classe di soci di risultare decisiva per l’adozione di alcune delibere.
6- La c.d. clausola di board rappresentation
Si è già ampiamente scritto in precedenza che la nomina degli organi societari può avvenire anche al di fuori del contesto dell’assemblea generale dei soci.
Una clausola normalmente negoziata in favore della classe di quotisti rappresentanti i soci senza diritto di voto o a voto limitato nell’assemblea generale è quella della c.d. “board rappresentation”39, che riconosce a detti soci il diritto di natura amministrativa di nominare e revocare parte dei componenti dell’organo amministrativo40.
Le finalità che spingono l’investitore a chiedere il diritto di nomina sono legate in primo luogo alla possibilità di concorrere con i soci fondatori alla definizione delle linee strategiche del business, creando un rapporto fiduciario con i soci fondatori, utile alla creazione di valore, e, solo secondariamente, alla necessità di avere strumenti di monitoraggio interno (si rinvia all’esempio esposto nel precedente par. 3).
Normalmente, per previsione statutaria, agli amministratori designati dai soci di mero capitale non spettano né deleghe operative né particolari emolumenti.
La legittimità di una decisione che sposta il luogo dell’elezione dell’organo amministrativo nelle assemblee speciali delle categorie di quote non sembra basarsi solo sull’esistenza di un pari diritto in capo al singolo socio come diritto particolare statutariamente previsto dall’art. 2468 comma 3 c.c., ma soprattutto sulla tesi dell’inapplicabilità nelle srl PMI del limite previsto dall’art. 2352 comma 2 c.c. e chiaramente sulla possibilità di prevedere categorie di quote con diritti diversi.
Il diritto di voto in capo all’assemblea speciale di categoria può essere modificato a seguito di un inadempimento (voting switch in case of default).
7 – Il diritto agli utili
I cosiddetti soci familiari di capitale normalmente negoziano la sottoscrizione di partecipazioni cercando di ottenere privilegi sia in termini di partecipazione agli utili durante societate sia in termini di partecipazione agli utili in sede di liquidazione41, che in qualche maniera fungano da contraltare all’esclusione dalla gestione diretta della società.
In dottrina, in riferimento a detti privilegi in termini di partecipazione agli utili, è stata coniata la distinzione tra partecipazioni di priorità e partecipazioni di preferenza (o privilegiate in senso stretto)42, che si basa sul criterio di ripartizione del risultato. Le partecipazioni di priorità incorporano il diritto a una attribuzione di utili con priorità rispetto alle altre partecipazioni, mentre le partecipazioni privilegiate danno diritto a una attribuzione di utili maggiore di quella spettante alle altre partecipazioni.
Tra le prime rientrerebbero le azioni con dividendo fisso, in caso di distribuzione degli utili, determinato con riferimento ad un certo parametro o in misura fissa, e che possono poi partecipare o meno alla distribuzione dell’ulteriore parte di utile residuo43. Tra le seconde rientrano le categorie di partecipazioni che, in termini quantitativi, attribuiscono una partecipazione più che proporzionale rispetto alle altre partecipazioni44.
Altra vicenda essenziale è l’individuazione del parametro eventualmente utilizzato per determinare il privilegio, sia esso di priorità o di preferenza. Detto parametro può essere individuato nel prezzo di sottoscrizione (comprensivo del sovraprezzo), come nel valore nominale delle partecipazioni.
Particolarmente interessante è la possibilità di prevedere il c.d. dividendo cumulativo45. La funzione di detta fattispecie è quella di impedire che il privilegio patrimoniale nella forma della partecipazione agli utili durante societate sia vanificato da decisioni improntate a un aggressivo ricorso all’autofinanziamento. Infatti, in ipotesi di ripetuta mancata distribuzione degli utili per diversi esercizi, in assenza della natura cumulativa del dividendo, non sembra possibile accedere a interpretazioni estensive del termine “utili netti” di cui all’art. 2350 comma 1 c.c., fino a ritenere che il diritto di priorità o preferenza si estenda anche alla porzione di utile accantonato negli esercizi precedenti e non distribuito ai soci.
Lo statuto dovrà, quindi, prevedere che i dividendi siano cumulativi, anche eventualmente permettendo che il recupero dei dividendi arretrati avvenga attraverso l’utilizzo dell’utile di bilancio o comunque di determinate riserve disponibili46.
Una clausola del genere ha l’effetto di garantire, in presenza di una deliberazione dell’utile, il pagamento degli importi arretrati derivanti dal privilegio sull’utile durante societate in pre-deduzione rispetto al pagamento del dividendo afferente all’esercizio di distribuzione e in aggiunta all’importo del dividendo da pagare ai soci privilegiati e ordinari afferente all’esercizio di distribuzione47.
Le clausole di dividendo cumulativo non tutelano, però, i soci privilegiati nel caso di mancata distribuzione di utili anche qualora,
nonostante la perdita di esercizio, residuino utili di bilancio. Per affrontare tale situazione è necessario prevedere statutariamente il c.d. dividendo obbligatorio, attraverso una automatica distribuzione di utili48.
È da precisare che le clausole che prescrivono una automatica distribuzione di utili, garantendo a una certa categoria di partecipazioni un dividendo obbligatorio, ovviamente sempre in caso di esistenza di un utile di bilancio distribuibile, non servono ad esonerare la società dalla deliberazione assembleare, quanto piuttosto a vincolare l’assemblea a una certa deliberazione, che se contraria alla pattuizione statutaria è annullabile49. L’unica perplessità riguarda la legittimità di clausola statutaria che imponga a priori la distribuzione di tutto l’utile di esercizio50.
8- Altri diritti di natura patrimoniale
Altri diritti di natura patrimoniale sono il diritto a sottoscrivere, in sede di aumento del capitale a pagamento, una partecipazione di valore più che proporzionale al conferimento. Sulla liceità di tale possibilità si è espressa la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la massima 154/2016, che così recita: “è legittima la clausola statutaria che attribuisce a uno o più soci un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta, valevole in tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento (fatta eccezione per gli aumenti in natura, ove previsti dallo statuto), fermo restando il diritto di recesso, in occasione di ogni decisione di aumento del capitale, ai soci cui spetta un diritto di opzione meno che proporzionale”51.
Una distribuzione dell’utile accantonato o una sua assegnazione non proporzionale mediante aumento gratuito del capitale riservato. È quanto ipotizzato da Commissione società del Consiglio Notarile di Milano con la massima 155/2016 che così si pronuncia: “è legittima la clausola statutaria che attribuisce a uno o più soci, in deroga all’art. 2481-ter, comma secondo, c.c., il diritto di ottenere in sede di aumento gratuito del capitale sociale un incremento della propria partecipazione in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta”52. Ancora, un diritto di prelazione nell’acquisto della partecipazione del socio recedente, alienante o escluso, di un diritto particolare di riscatto su quote. Anche in questa ipotesi si è espressa la Commissione società del Consiglio Notarile di Milano con la massima 153/2016 che così scrive: “sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci di srl o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l’applicabilità della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (art. 2473, comma terzo, c.c.)”.
Tra i diritti patrimoniali c.d. speciali è da annoverarsi anche la clausola di prelazione a favore delle quote di categoria nella sottoscrizione delle quote rimaste inoptate.
È possibile inoltre, prevedere una postergazione nelle perdite53 che attribuisce al titolare della quota speciale il privilegio di partecipare alle perdite in via subordinata e, precisamente, solo dopo che le medesime abbiano inciso sulle altre partecipazioni54. Operativamente la postergazione si manifesta nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite55.
Analogamente a quanto previsto con riferimento alle partecipazioni privilegiate agli utili durante societate, anche le partecipazioni postergate possono essere configurate come partecipazioni postergate prioritarie o come partecipazioni postergate di preferenza56. È ammessa anche una clausola che differenzi nella imputazione delle perdite tra riserve disponibili e capitale sociale, per esempio, prevedendo che le perdite incidano in misura proporzionale fino alla erosione di tutte le riserve disponibili e poi in misura variamente prioritaria o preferenziale sulla cifra del capitale sociale a favore delle partecipazioni postergate; oppure, viceversa, prevedendo che le perdite incidano in misura variamente prioritaria o preferenziale a favore delle partecipazioni postergate fino alla erosione di tutte le riserve disponibili e poi in misura proporzionale sulla cifra del capitale sociale. Il problema delle partecipazioni postergate nasce nell’ipotesi in cui, per effetto della riduzione del capitale per perdite, tutte le quote ordinarie siano annullate e, all’esito dell’operazione, residuino solo le quote postergate nelle perdite con diritto di voto limitato o escluso. Nelle spa tale problematica è stata risolta dalla dottrina mediante applicazione analogica (statutaria) del comma 5 dell’art. 145 del TUF57, dettato per le azioni di risparmio. Ciò è richiesto anche nel nostro caso. È pertanto opportuno che lo statuto della srl/PMI modificata individui espressamente dei correttivi al riguardo anche, se del caso, riproducendo (con eventuali variazioni) nello statuto della srl, il disposto del 145 del TUF, che prevede una tempistica stringente per ristabilire il rapporto di equilibrio tra quote ordinarie da attribuire in prelazione ai titolari di quote ordinarie, pena lo scioglimento della società.
9- Le clausole di covendita, in particolare la clausola di tag along
Ulteriore diritto che viene negoziato è quello di cedere le proprie partecipazioni nell’eventualità che il socio familiare manager ceda la propria partecipazione di controllo, c.d. “clausola di tag along”58. Detta clausola, che la CONSOB ha previsto debba obbligatoriamente essere inserita a tutela del socio investitore nell’ipotesi di collocazione della quota presso il pubblico dei finanziatori (mediante crowdfunding), è, ad avviso di chi scrive, altrettanto necessaria in favore dei soci di categoria depotenziati nel loro diritto di voice con l’esclusione spesso quasi totale del diritto di voto. Il diritto di co-vendita delle partecipazioni è fenomeno di provenienza anglosassone che comporta una serie di declinazioni molteplici e tra loro non simili59. Il termine covendita pare potersi riferire a due ipotesi simili ma diverse di clausole mutuate dai regimi anglosassoni, ossia le clausole di right of co-sale chiamate anche clausole di tag-along normalmente disciplinate nei patti sociali unitamente alle clausole di drag-along e bring along60.
Parte della dottrina afferma che l’interesse sotteso alla clausola può indifferentemente appartenere tanto al socio di maggioranza, da intendersi quale soggetto titolare del diritto a co-vendere, quanto al socio di minoranza.
Quale interesse del socio di maggioranza la clausola (normalmente di drag-along) persegue l’obiettivo di rendere più appetibile la cessione della propria partecipazione, negoziando con il terzo cessionario il trasferimento di una porzione di capitale più ampia rispetto a quella detenuta ed offrendo così al potenziale acquirente il controllo della società e la neutralizzazione dei diritti attribuiti alla minoranza61.
Detti diritti, in particolare, sono rappresentati in statuto da maggioranze assembleari rafforzate, dirette ad attribuire il diritto di veto al socio di minoranza su alcune determinate materie di competenza dei soci62.
Stesso discorso varrebbe per le deliberazioni collegiali di competenza dell’organo amministrativo qualora sia stato attribuito al socio di minoranza il diritto a designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione tramite l’inserimento in statuto del procedimento del voto di lista o, a seconda del modello societario scelto, di un diritto particolare a designare uno o più amministratori. In tal caso, è possibile infatti che siano previsti quorum rafforzati anche per il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire l’approvazione di certe decisioni solo con il voto del consigliere espressione della minoranza. I precedenti non sono gli unici punti di criticità per un’operazione di acquisizione. Infatti, anche in assenza di quorum rafforzati il socio di srl può attivare poteri come quello ispettivo il cui abuso può comunque creare grossi problemi alla società, salvo che si condivida con chi scrive circa l’opportunità/necessità di privare statutariamente il socio mero investitore di detti poteri perlomeno in determinate ipotesi. Proprio in tali situazioni la tutela che deriva da una clausola di co-vendita “protegge l’interesse alla liquidazione dell’investimento ed evita l’opportunismo del socio di minoranza”63. Inoltre, con il trasferimento al terzo dell’intero capitale sociale, il socio titolare della partecipazione di maggioranza riesce anche a garantirsi il diritto di ottenere un extra-premio da controllo totalitario64. Nell’ottica del socio di minoranza, il meccanismo sotteso alla clausola (normalmente di tag-along) consente certamente un aumento del valore della porzione di capitale detenuta; di ottenere per la propria partecipazione le medesime condizioni economiche offerte dal terzo cessionario ed accettate dal socio di controllo e permette al socio di minoranza di evitare la convivenza con un socio di maggioranza non gradito o comunque estraneo. Tuttavia, le c.d. “clausole di co-vendita”, definite, come altre, “aliene” dalla dottrina proprio perché “importate” da altri ordinamenti65, sono da vagliare alla luce del nostro sistema giuridico, “in quanto non necessariamente una qualsiasi prassi contrattuale proveniente dall’estero è conforme ai principi del nostro ordinamento”66.
Il c.d. “tag-along” (italianizzato patto di accodamento) prevede che qualora il socio di controllo voglia cedere la partecipazione debba permettere ai soci di minoranza di vendere le proprie partecipazioni alle medesime condizioni concordate con l’acquirente, sfruttando la forza contrattuale del socio di controllo. La clausola prevede che il cessionario acquisti anche la partecipazione dei soci di minoranza e determina la sospensione dell’efficacia della vendita della partecipazione da parte del socio che esercita il controllo per un certo periodo di tempo, durante il quale i soci di minoranza decidono se accodarsi all’alienazione proposta dal socio di controllo, imponendo la vendita anche delle loro partecipazioni. Nel caso in cui i soci finanziatori di minoranza decidano di esercitare il diritto derivante dalla clausola di tag-along, verrà definita una nuova proposta di vendita da proporre all’acquirente. Qualora l’acquirente non accettasse detta proposta, il socio di controllo non potrebbe cedere la propria partecipazione. La clausola di tag-along è valutata con benevolenza dalla dottrina perché in realtà attribuisce al socio di minoranza un diritto potestativo, potendo il socio di minoranza liberamente scegliere se vendere o meno la propria quota di partecipazione alle stesse condizioni e allo stesso prezzo del socio di maggioranza. Non si potrebbe, di conseguenza, configurare l’effetto avversato dalla giurisprudenza e da parte della dottrina di esclusione del socio dalla compagine sociale, in assenza di una sua manifestazione di volontà. Si ritiene che la clausola in oggetto vada ricondotta nell’alveo delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni introducibili a maggioranza. La vera questione sembra però essere, per chi scrive, la regolamentazione statutaria, in presenza di una clausola espressa di tag-along, delle conseguenze nascenti dal legittimo rifiuto di uno o più soci di minoranza “investitori” di non esercitare il diritto potestativo di partecipare alla vendita, con la conseguente impossibilità per il terzo acquirente di acquistare tutte le loro partecipazioni. Per una tesi restrittiva le partecipazioni di minoranza costituirebbero insieme a quelle di maggioranza l’oggetto inscindibile del negozio e di conseguenza i soci di maggioranza (o, meglio nel nostro caso di controllo) non potrebbe alienare nemmeno le proprie partecipazioni67. A chi scrive sembra opportuno ritenere che, a fronte dell’eventuale rifiuto di uno dei tanti soci di minoranza di fruire del proprio diritto, il socio di controllo resti pur sempre libero di vendere la sua partecipazione68, sempre che ciò soddisfi il terzo acquirente69. La prassi statutaria normalmente inserisce anche una clausola punitiva (nella forma di una put-option) per il caso in cui il socio di maggioranza ometta, tramite la mancata comunicazione-denuntiatio, di far partecipare il socio di minoranza alla cessione al terzo (così violando il diritto di co-vendita).
In questi casi i soci di minoranza potrebbero pretendere che il socio di controllo acquisti le loro partecipazioni alle medesime condizioni offerte dal terzo.
La clausola di co-vendita e il suo contenuto sono riassunti e semplificati, ma la realtà contrattuale presenta clausole ben più complesse e articolate che lasciano spazio alla “fantasia statutaria”. Nel corso delle negoziazioni relative alla strutturazione di un’operazione di private equity può verificarsi un impasse proprio in relazione al coordinamento tra il diritto di prelazione e il diritto di tag-along: da un lato, il socio di maggioranza, di solito, non vuole concedere ai soci di minoranza il diritto di prelazione, temendo di subire il tipico effetto disincentivante dell’interesse di potenziali terzi acquirenti; dall’altro lato, i soci di minoranza, ai quali sia concesso il diritto di tag-along, temono che il socio di maggioranza, non avendo l’onere della prelazione, possa svendere la sua partecipazione, rendendo di fatto non esercitabile il diritto di co-vendita.
In tali situazioni, è possibile risolvere il problema prevedendo che:
– la prelazione possa essere esercitata solo qualora il prezzo della prospettata vendita sia inferiore a una certa soglia predeterminata (magari con una formula tale da rendere “mobile” la medesima soglia in funzione degli scostamenti positivi/negativi del patrimonio netto della target company e/o della relativa posizione finanziaria netta e/o
del relativo capitale circolante netto);
– il diritto di tag-along possa essere esercitato, qualora il prezzo della prospettata vendita sia superiore alla predetta soglia.
Per questa via, si garantisce, in modo intelligente, l’equa commisurazione del prezzo della prospettata vendita (in linea con l’arm lenght principle), in quanto, da un lato, il socio di maggioranza sarà vieppiù indotto a spuntare un prezzo superiore alla soglia di riferimento; dall’altro lato, i soci di minoranza potranno profittare della prelazione, qualora il prezzo della prospettata vendita sia inferiore al valore (convenzionalmente ritenuto) equo e proteggersi dal rischio di un surrettizio “ingigantimento” del prezzo, per eludere il diritto di prelazione, del quale essi potrebbero comunque profittare, esercitando il diritto di tag-along. Qualora, invece, la pattuizione di prelazione “conviva” con quella di drag- along, al fine di evitare possibili “corto-circuiti” tra le due pattuizioni, nella prassi è spesso previsto che, in caso di esercizio del diritto di drag-along, il diritto di prelazione non possa essere esercitato.
La giurisprudenza ha affermato che in presenza di una clausola di drag-along è necessario assicurare ai soci trascinati meccanismi di “equa valorizzazione” della loro partecipazione, non costituendo tutela altrettanto esaustiva la previsione in capo al socio di minoranza del diritto di prelazione70.
In realtà, l’interesse dei soci nel prevedere tali clausole sembra meritevole di tutela, visto che: in primo luogo, l’alienazione congiunta di più partecipazioni nei confronti del medesimo soggetto avviene, di solito, a condizioni di vendita migliori rispetto a quelle che si hanno in caso di alienazioni distinte e separate71; in secondo luogo, può accadere che due o più soggetti/soci siano tra loro vincolati da un determinato legame, quale quello derivante da un rapporto di fiducia o di collaborazione, tale per cui è interesse delle parti stesse che non vi subentrino terzi soggetti72; in terzo luogo il terzo acquirente potrà evitare la convivenza in società con una minoranza potenzialmente ostile, evitando il rischio che la minoranza alieni la propria partecipazione a terzi non graditi73; in quarto luogo, la clausola tutela l’interesse della società ad evitare eccessi di dialettica interna tra i soci, ovvero forme di ostruzionismo da parte della minoranza suscettibili di degenerare in un cattivo funzionamento dell’ente, concentrando il potere di alienare tutte le partecipazioni in capo ad un unico soggetto e garantendo, conseguentemente, l’omogeneità della compagine sociale74.
Non solo, le clausole in esame soddisfano ulteriori interessi: ad esempio nel caso di compagine sociale composta da un socio maggioritario finanziatore/imprenditore, che fornisce alla società quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e da una pletora di piccoli soci investitori, arruolati magari attraverso un’operazione di crowdfunding, animati esclusivamente da finalità speculative; in questa situazione con tale clausola si consentirebbe ai soci di minoranza di vendere le loro partecipazioni allo stesso prezzo spuntato dal socio di maggioranza sebbene esse, essendo percentualmente irrilevanti, abbiano un valore di mercato sensibilmente inferiore. Per quanto qui di interesse, la clausola di drag-along potrebbe assumere una rilevanza al fine di veicolare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia75, con l’avvio all’attività sociale dei figli (non è infrequente, infatti, che uno solo dei figli prosegua di fatto l’attività paterna mentre gli altri se ne disinteressino ovvero, più semplicemente, manchino di capacità imprenditoriale per continuarla). In tal caso, al fine di fornire adeguata ed eguale tutela a tutti i figli il padre/imprenditore, predisponendo la clausola di trascinamento, potrebbe ottenere il duplice risultato di creare un legame di connessione tra il figlio dotato di capacità imprenditoriale e gli altri figli, consentendo al primo di poter disporre dell’intera società a vantaggio di tutti e di evitare che, nel caso in cui lo stesso decida di porre fine alla sua partecipazione nella società, gli altri restino in balia di un soggetto estraneo. Non solo, attraverso una clausola di trascinamento, un genitore, fondatore dell’impresa di tipo familiare, ma che di fatto vuole mantenere saldamente nelle sue mani la possibilità di vendere l’intera società senza essere costretto a rimettersi alla volontà dei figli, può agevolmente riservarsi tale diritto. Infine, qualora ad un socio di minoranza di una srl sia stato attribuito, in ragione delle comprovate qualità tecnico-manageriali, un diritto particolare di veto sulle nomine dei membri dell’organo amministrativo, il ricorso alla clausola di trascinamento rappresenta la risposta più efficace per chi intenda acquisire effettivamente il controllo della società.
10 – La fissazione del compenso amministratori quale diritto particolare del socio
L’art. 2389 comma 1 c.c., in materia di spa, prevede che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”. La disciplina attuale delle srl, invece, nulla prevede in merito al compenso degli amministratori. A seguito della riforma delle società di capitali del 2003, infatti, è stato espunto il riferimento, precedentemente contenuto nell’art. 2487 c.c., alla disciplina dei compensi prevista per le spa dall’art. 2389 c.c., né si rinviene alcun riferimento al compenso amministratori nell’art. 2475 c.c., che riguarda l’amministrazione della società nelle srl, o nell’art. 2479 comma 2 c.c., che attribuisce alla competenza dei soci di srl la nomina degli amministratori76. La giurisprudenza ritiene, comunque, applicabile anche alla srl l’art. 2389 c.c., in tema di spa, e quindi ritiene che anche in assenza di un’espressa previsione in sede di costituzione della società, gli amministratori abbiano diritto al compenso e che competa ai soci determinarlo77. È opportuna in materia una pattuizione stautaria che predetermini un limite massimo alla determinazione dei compensi annui dei soci amministratori, magari opportunamente agganciata ai risultati conseguiti nell’esercizio, in tal modo garantendo ai soci che non partecipano all’amministrazione comunque la percezione di un utile (dedotti previamente i compensi amministratori). Si deve ricordare, infatti, che spesso nella srl (a differenza delle spa) la nomina degli amministratori è a tempo indeterminato e che di principio il compenso stabilito per gli amministratori all’atto della nomina non può essere modificato (in senso deteriore) per tutta la durata della carica in mancanza del consenso degli stessi amministratori. È, pertanto, opportuna una regolamentazione statutaria della fattispecie, ad esempio, con meccanismi affini a quelli delle c.d. claw back clauses (sono clausole che prevedono la possibilità di esigere la restituzione parziale dei compensi nel caso di mancato raggiungimento di risultati da parte della società amministrata)78. La prassi si interroga se, con i dovuti accorgimenti sopra enunciati, sia possibile configurare un diritto particolare di un socio, ex art. 2468 comma 3 c.c., consistente nella fissazione del compenso amministratori. Detto eventuale diritto particolare alla fissazione del compenso si collocherebbe in una sorta di posizione intermedia rispetto ai diritti particolari enunciati dal codice inerenti, da un lato, al diritto di amministrare la società e, dall’altro, al diritto alla percezione dell’utile prodotto dall’impresa. La previsione di un diritto particolare del socio alla fissazione del compenso quale amministratore, calcolato secondo una equa percentuale (es non superiore al 25% dell’utile) sembra, pertanto, a chi scrive, ammissibile anche alla luce dell’ampia autonomia che il legislatore della riforma del 2003 ha assegnato ai soci.
Conclusioni
La srl PMI79 si pone all’attenzione dell’operatore del diritto come strumento di straordinaria duttilità, potendo prevedere sia una quota dotata di diritti particolari ex art. 2468 comma 3 c.c., con la quale il capofamiglia può conservare la facoltà di amministrare e mantenere altri vantaggi riguardanti la gestione della società, che, del pari assegnare, attraverso le categorie di quote con diritti speciali80, prerogative riguardanti la distribuzione degli utili con le quali offrire una data remunerazione al familiare che svolge un ruolo nevralgico nella gestione dell’impresa, nel contempo assicurando ad alcuni familiari una rendita, sulla base di considerazioni di carattere personale.
Il legislatore finalmente attinge ai modelli di srl europei. Ciò vale, ad esempio, per le vorzugsge-schàftsanteile tedesche, che permettono la circolazione con la quota di determinati diritti speciali, nonché per le società spagnole che ammettono in particolari ipotesi l’introduzione di participaciones privilegiadas, spingendosi, in qualche occasione, a consentire l’introduzione di quote a voto plurimo e, in altre, le partecipaciones sin voto81, e infine per la srl olandese, riformata nel 2012, che ha legittimato l’emissione di quote con voto limitato e senza voto82.
La srl PMI consente finalmente anche in Italia di introdurre categorie di quote includenti benefici speciali o all’opposto restrizioni. Siffatto meccanismo permette di distinguere il regime giuridico applicabile a singoli gruppi familiari, in quanto gli eredi ricevono una partecipazione sociale che include in sé vantaggi o limitazioni predeterminati. Per questa via, inoltre, la distinzione della posizione dei soci è replicabile anche dopo l’ingresso dei discendenti, in quanto ciascun gruppo familiare risulta destinatario di partecipazioni che hanno specifiche caratteristiche, così da lasciare inalterati i rapporti di forza anche successivamente al mutamento della compagine sociale, che si verifica con l’inserimento delle nuove generazioni83.
Questo strumento è destinato a diventare la strada più idonea per articolare finalmente l’impresa familiare.
1 Sulla composizione familiare delle nostre srl e sui rischi conseguenti all’insorgere di un dissidio familiare che si riflette sull’attività di impresa, ampiamente Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale”, Torino, 2024. Il presente studio in tema di società familiari e passaggio generazionale segue al precedente studio: Busi C.A. “Il passaggio generazionale nelle società familiari”, in questa Rivista, 6, 2022.
2 Circa la scelta del modello societario: Magli C. “Note critiche sul passaggio generazionale dell’impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust”, Contr. impr., 2019, p. 1617; Pellegrino S., Recchioni L. “Holding: sei punti chiave per scegliere tra srl, società semplici e trust”, Il Sole 24 Ore, 11.12.2023, p. 26; Busani
A. “Sì alle società semplici cassaforte”, ivi, 6.7.2016, p. 42; Talice P. “La società semplice immobiliare”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 1, 2022; Piscitello P. “Passaggi generazionali e gestione dell’impresa nelle società di persone”, Riv. dir. soc., 2014, p. 36; Peta M. “Il passaggio generazionale d’impresa nelle operazioni di riorganizzazione”, Notariato, 2021, p. 681; Balestra L. “Autonomia negoziale nella s.r.l. a compagine familiare: la personalizzazione della partecipazione”, Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 14; Poli S., Vancini A. “La scelta del tipo di società tra coniugi (e familiari) tra fisiologia e patologia della società e della famiglia”, Familia, 2005, I, p. 735. Sull’argomento delle società familiari si veda anche Cetra A. “La partecipazione di società di capitali in società di persone nel passaggio generazionale dell’impresa”, in AA.VV. “La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo”, Torino, 2011, p. 181.
3 Scaglione F. “Clausole societarie di successione familiare”, Contr. e impr., 2009, p. 943; Palazzo M. “Testamento e strumenti alternativi di trasmissione della ricchezza”, in “Imprese a base familiare. Strumenti di successione”, a cura di Bucelli A., Bencini R., www.personaemercato.it, 2015, p. 45.
4 Talice P. “Le quote di categoria di srl-PMI come strumento idoneo a soddisfare interessi diversi dalla raccolta di capitali”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 10, 2018, p. 17.
5 Busi C.A. “I quorum elevati a salvaguardia delle minoranze e i quorum necessari per la loro modificazione”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 7-8, 2017; Id. “Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata”, in “Trattato di diritto dell’economia”, diretto da Picozza F., Gabrielli F., Padova, 2008, Vol. IV.
6 Sul tema: Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale” cit.
7 Civerra E. “Diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c.: una fiducia ben riposta”, Società, 2020, p. 43.
8 Sul tema si veda ampiamente Busi C.A. “La prelazione societaria”, Milano, 2019.
9 Busi C.A. “Le nuove s.r.l.”, Torino, 2021, p. 483.
10 In materia: Anderson R.C., Ottolenghi E., Reeb D.M. “The dual-class premium: a family affair”, 2017, SSRN Scholary paper n. id. 3006669, Rochester, NY: Social science research network; Bennedsen M., Nielsen K.M., Perez Gonzales F., Wolfenzon D. “Inside the family firm: the role of families in succession decisions and performance”, The Quarterly Journal of economics, 2007, 122, 2, p. 647-691.
11 Limatola C. “Passaggi generazionali e posizioni di governo nella s.r.l.”, Torino, 2017, p. 237.
12 Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 505; Talice P. “Le quote di categoria di srl-PMI come strumento idoneo a soddisfare interessi diversi dalla raccolta di capitali” cit.
13 Talice P. “Le quote di categoria di srl-PMI come strumento idoneo a soddisfare interessi diversi dalla raccolta di capitali” cit., p. 17.
14 L’esenzione per il trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, a favore del coniuge o del discendente del donante opera a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento. A tal fine, è necessario che i discendenti e/o il coniuge beneficiari del
trasferimento rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, una dichiarazione che attesti la volontà di proseguire l’attività per il termine di 5 anni.
15 Sul tema si vedano: Margheri C., Susini F.“Il passaggio generazionale di quote societarie mediante atti inter vivos: le risposte ad interpello n. 37 e 38”, in questa Rivista, 3, 2020; Busani A. “L’agevolazione per il passaggio generazionale dell’azienda”, Società, 2018, p. 1219; Id. “L’agevolazione per il passaggio generazionale delle azioni e delle quote di partecipazione al capitale sociale”, ivi, 2018, p. 1353; Mastroiacovo V. “La partecipazione indiretta di quote societarie integra il controllo utile per l’esenzione”, Corr. trib., 2010, p. 2889; Stevanato D. “I trasferimenti di aziende e partecipazioni nell’imposta di
successione e donazione: aspetti critici delle nuove fattispecie di esenzione”, Dial. dir. trib., 2007, p. 502.
16 In tema è però da evidenziare il recente intervento della Cass. 28.2.2023 n. 6082, in Sistema Integrato Eutekne, secondo cui l’agevolazione dell’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 presuppone non solo l’acquisizione del controllo della società e il suo mantenimento per almeno un quinquennio, ma anche l’esercizio dell’impresa da parte della società partecipata, per cui non spetta nel caso di donazione ai figli di quote di partecipazione al capitale di società di “mero godimento immobiliare”, poiché il trasferimento del controllo di società che non hanno un’effettiva ed operativa attività economica non è equivalente al trasferimento di un’azienda. Sulla sentenza criticamente: Loconte S., Molteni B. “Passaggio generazionale del patrimonio societario familiare: requisito dell’esercizio dell’attività di impresa”, il fisco, 2023, p. 1643; Busani A. “Tassazione agevolata del patto di famiglia solo se vi è esercizio di attività di impresa: una opinabile decisione additiva della Cassazione”, Società, 2023, p. 805; Tassani T. “Trasferimento di partecipazioni ed esercizio effettivo dell’impresa: storia di un disorientamento interpretativo”, Riv. di giur. trib., 2023, p. 601; Foglia G., Cecci M. “Esenzione da imposta sulle donazioni per il trasferimento di quote sociali: prevale l’interpretazione teleologica”, Corr. trib., 2023, p. 472.
17 Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 575.
18 Bisognerà poi prestare particolare attenzione al possibile insorgere di dissidi tra i discendenti, prevedendo ex ante meccanismi statutari o parasociali di soluzione dello stallo decisionale: vedi Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale” cit., p. 551.
19 L’equilibrio tra posizioni contrattuali costituisce un efficace deterrente all’insorgere di gravi dissidi tra soci familiari vedi Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale” cit., p. 29.
20 Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 655.
21 Detto risultato è raggiungibile anche con il voto di lista; per una recente panoramica sull’argomento Passador M.L. “Lineamenti di un’analisi comparata sul voto di lista: alla ricerca del ruolo della minoranza”, Riv. dir. soc., 2018, p. 935.
22 In materia: Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 654; Bohrer S.D. “Protecting the rights of minority shareholders”, Private-owned companies, Insights, 4, 2007, p. 15-25.
23 Sulla possibile attribuzione a singoli amministratori di un potere di veto si veda Spiotta M. “L’esercizio del diritto di voto nel CdA”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 9, 2018, p. 15-16.
24 Sul tema: Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale” cit., p. 218.
25 Sul tema: Busi C.A. “Le clausole anti-diluizione e le operazioni di aumento del capitale nelle srl”, Società e Contratti, Bilancio
e Revisione, 11, 2021; Id. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 672; Abu Awwad A. “Il problema delle clausole anti-diluitive”, Nuove leggi civ. comm, 2021, I, p. 175.
26 App. Milano 13.2.2020, in Sistema Integrato Eutekne.
27 Sull’ argomento: Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 712.
28 Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 650.
29 In tema Bertini L.M. “Le azioni a voto limitato, condizionato, contingentato e scaglionato”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 5, 2018, p. 18. Ammette il voto capitario Guizzardi S. “La srl innovativa”, in appendice di aggiornamento 2016-2017 di “La nuova società a responsabilità limitata”, a cura di Bione M., Guidotti R., Pederzini E., in “Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia”, Milano, 2017, p. 76.
30 Massa Felsani F. “In tema di scaglionamento del voto e principio di uguaglianza”, Riv. dir. impr., 2011, p. 659; Pomelli A. “Rischio d’impresa e potere di voto nelle società per azioni: principio di proporzionalità e categorie azionarie”, Giur. comm., 2008, I, p. 510.
31 Calvosa L. “La partecipazione eccedente e i limiti al diritto di voto”, Milano, 1999, p. 165.
32 Blandini A. “Le azioni a voto limitato nella riforma”, Giur. comm., 2004, I, p. 483.
33 Busi C.A. “Applicabili nelle srl molte norme delle spa: le regole nei nuovi atti costitutivi”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 1, 2018, p. 15.
34 Marchisio E. “La maggiorazione del voto (art. 127 quinquies T.U.F.): récompense al socio stabile o trucage del socio di controllo?”, Banca borsa tit. cred., 2015, I, p. 80.
35 In materia: Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 654; Bohrer S.D. cit.
36 È chiaro che il rafforzamento del potere decisionale di categorie di soci può portare allo stallo decisionale che richiede ulteriori accorgimenti statutari per il suo superamento; vd. Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale” cit., p. 155.
37 Donativi V. “Strumenti di corporate governance tra fondi di private equity e PMI”, Banca borsa tit. cred., 2008, I, p. 205, sottolinea che i diritti di veto normalmente riconosciuti al venture capitalist includono tutte le decisioni che possono avere
una ricaduta significativa sull’investimento effettuato e sulle aspettative di ritorno economico. In tal caso, qualora si tratti di delibere del Consiglio di Amministrazione, il socio fondatore di controllo si impegnerà, anche eventualmente quale promessa del fatto del terzo, a far sì che gli amministratori da lui nominati non pongano in essere, senza il previo consenso del venture capitalist, operazioni rientranti nella tipologia e/o negli importi contrattualmente predefiniti.
38 In tema Guarini M. “Il consenso determinante della minoranza nelle società di capitali tra clausole di salvaguardia e abuso di potere”, Riv. dir. soc., 2018, p. 352.
39 Sahlman W.A. “The structure and governance of venture-capital organizations”, Journal of financial economics, 1990, 2, p. 473-521.
40 Li T., Zaiats N. “Corporate governance and firm value at dual class firm”, Review of financial economics, 2018, p. 47-71.
41 Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 666.
42 In materia: Sfamemi P. “Azioni di categoria e diritti patrimoniali”, Milano, 2008, p. 109; in precedenza Fontana S. “Le azioni privilegiate nella prassi statutaria”, Giur. comm., 1976, I, p. 516.
43 Caruso C. “Conformazione statutaria del privilegio reddituale e definizione legale del contenuto delle azioni (di risparmio)”, Banca borsa tit. cred., 2003, II, p. 1244.
44 Abriani N., aggiornato da Dell’osso A., sub art. 2348, in “Codice delle società”, a cura di Abriani N., Torino, 2016, p. 670.
45 Si sono interessate a detta fattispecie App. Milano 28.9.2001 e Trib. Milano 22.5.2000, Banca borsa tit. cred., 2003, II, p. 1244.
46 Fontana S. cit., p. 522.
47 Giampaolino C.F. “Le azioni speciali”, Milano, 2004, p. 153.
48 Per l’ammissibilità: in giurisprudenza Trib. Trani 19.9.2000, Società, 2001, p. 481, con nota di Fico D. “Distribuzione degli utili in assenza di delibera assembleare”; in dottrina: Sfamemi P., sub art. 2350, in “Le azioni”, in “Commentario alla riforma delle società”, a cura di Marchetti P., Bianchi L, Ghezzi F., Notari M., Milano, 2008, p. 231.
49 Così App. Milano 28.9.2001 cit. e Trib. Milano 22.5.2000 cit.
50 Ferri G. “Diritto agli utili e al dividendo”, Riv. dir. comm., 1963, I, p. 637.
51 Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 754.
52 Ruotolo A., Boggiali D. “Assegnazione di partecipazioni non proporzionali in sede di aumento gratuito del capitale”, Quesito impresa n. 155-2015; Onza O. “Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto sociale (appunti sulla derogabilità convenzionale della proporzione tra conferimento e quote”, Riv. dir. civ., 2007, II, p. 718; Sodi I. “L’assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali”, Studi e materiali, 2009, p. 584. In generale sull’argomento: Busi C.A. “Aumento del capitale nelle s.p.a. e s.r.l.”, Milano, 2013, p. 176.
53 Pomelli A. cit., p. 522, osserva che con l’ammissibile previsione di una partecipazione al rischio d’impresa graduata e condizionata alla preventiva sopportazione delle perdite da parte di alcuni azionisti, il principio di correlazione potere-rischio dovrebbe essere, almeno nei termini in cui è stato tradizionalmente invocato, notevolmente ridimensionato.
54 Per il rapporto con il patto leonino si vedano: Occorsio V. “Clausola leonina”, in “Clausole negoziali”, a cura di Confortini M., Torino, 2017, p. 1147.
55 A favore: Trib. Udine 25.11.1981 e Trib. Udine 10.4.1981, Giur. comm., 1982, II, p. 884. In dottrina: Libertini M., Mirone A., Sanfilippo M., sub art. 2348, in “Commentario romano al nuovo diritto delle società”, a cura di d’Alessandro F., Padova, 2010, p. 248.Con specifico riferimento alle srl PMI, Butturini P. “I diritti particolari dei soci: profili generali”, in “La governance delle società a responsabilità limitata”, a cura di Pederzini E., Guidotti R., Milano, 2018, p. 104.
56 Abriani N., sub art. 2348, in “Il nuovo diritto societario”, Commentario diretto da Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., Bologna, 2004, p. 272.
57 “Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l’ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito
entro i termini predetti”.
58 Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale” cit., p. 218; Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit., p. 703.
59 Si veda Santangelo S. “Clausole di covendita: strumento indispensabile per compagini sociali disomogenee”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 11, 2018.
60 De Matteis L. “La clausola di trascinamento inserita nello statuto di una società a responsabilità limitata e criteri redazionali”, Giur. comm., 2017, I, p. 643. Vd. anche Santangelo S. “Clausole di trascinamento drag along e bring along: strapotere capitalistico o soggezione di interesse?”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2, 2019.
61 Giampaolino C.F. “Clausola di co-vendita (drag along) ed equa valorizzazione dell’azione”, Banca borsa tit. cred., 2009, II, p. 525.
62 In motivazione nel senso del testo Trib. Milano 31.3.2008, in Sistema Integrato Eutekne.
63 Giampaolino C.F. “Clausola di co-vendita (drag along) ed equa valorizzazione dell’azione” cit.
64 Di Bitonto C. “Clausole statutarie di c.d. drag along: chi era costei?”, Società, 2008, p. 1381.
65 De Nova G. “The alien contract”, Riv. dir. priv., 2011, p. 487; Id. “Il contratto alieno”, Torino, 2008.
66 Sangiovanni V. “Le pattuizioni di co-vendita quali limiti alla circolazione di azioni e quote”, Notariato, 2013, p. 696.
67 Del Linz M. “L’introduzione delle clausole di co-vendita negli statuti sociali”, Giur. comm., 2012, II, p. 1077.
68 Divizia P. “Clausole di drag-along e tag-along e modalità di funzionamento”, Notariato, 2011, p. 404.
69 Sull’argomento App. Milano 27.9.2012 n. 3099, in Sistema Integrato Eutekne.
70 Trib. Milano 22.12.2014, in Sistema Integrato Eutekne.
71 Pistocchi C., Puleo J.A. “Meccanismi di exit dalla società: evoluzione della prassi e codificazione statutaria degli accordi tra soci”, in questa Rivista, 6, 2018, p. 23.
72 D’Alessandro C. “Patti di co-vendita tag along e drag along”, Riv. dir. civ., 2010, p. 373.
73 Santangelo S. “Clausole di trascinamento drag along e bring along: strapotere capitalistico o soggezione di interesse?” cit., p. 28.
74 Santangelo S. “Clausole di trascinamento drag along e bring along: strapotere capitalistico o soggezione di interesse?” cit., p. 28.
75 Busi C.A. “Le società familiari (c.d. “FBS”) in forma di srl” in “Le nuove s.r.l.” cit., p. 483; Id. “Il passaggio generazionale nelle società familiari” cit.
76 Sul tema: Antonini V. “Amministratori di s.r.l. e diritto al compenso”, Riv. dir. civ., 2022, p. 777; Magliona C.B. “Determinazione dei compensi e conseguenze della violazione dell’art. 2389 c.c.”, Giur. It., 2023, p. 2409; Bonafini L. “I compensi degli amministratori di società per azioni”, Milano, 2005, p. 347; Petrazzini B. “Compenso degli amministratori e assemblea sociale: l’intervento delle Sezioni Unite”, Giur. It., 2009, p. 1183; Sangiovanni V. “La quantificazione del compenso dell’amministratore di s.r.l.”, Giur. merito, 2011, p. 2750; Folladori L. “Sulla determinazione del compenso degli amministratori di s.r.l.”, ivi., 2009, II, p. 1144; Corso S. “La speciale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nella società a responsabilità limitata”, Giur. comm., 2009, II, p. 485.
77 Cass. 20.2.2009 n. 4261, in Sistema Integrato Eutekne; Trib. Roma 8.6.2020, ivi e Società, 2021, p. 934, con nota di Perrino M. “Compensi e buonuscita dell’amministratore delegato di s.p.a.: problemi di competenza”.
78 In argomento Rugolo G. “Compensi variabili, claw back clauses e regolamentazione del rapporto di amministrazione”, Riv. dir. soc., 2017, p. 385.
79 In tema: Busi C.A. “Le nuove s.r.l.” cit.; Id. “La nuova srl PMI alla luce dei recenti orientamenti notarili”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 7-8, 2019; Id. “Applicabili nelle srl molte norme delle spa: le regole nei nuovi atti costitutivi” cit.; Id. “Le modifiche statutarie per la gestione del crowdfunding nelle srl PMI”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2, 2018, p. 16.
80 Famoso il caso della Robert Bosch GmbH, le cui quote risultano, per una percentuale pari al 91% del capitale sociale nominale, senza voto e detenute dalla fondazione di famiglia.
81 Cfr. Campuzano A.B., sub artt. 98-103, in “Comentario de la ley de sociedades de capital”, diretto da Rojo A., Beltràn E., 2011, p. 845, che sottolinea l’utilizzo delle partecipazioni senza voto come tecnica di riserva della gestione della società a
determinati soci.
82 Wolf R.A. “De kapitaalverschaffer zonzer stmrecht”, in de BV, Maastricht, 2013; Zaman N. “Die niederlàndische flex-BV”, GmbHr, 2012, p. 1065.
83 Sempre con grande attenzione a possibili dissidi e alla loro risoluzione, Busi C.A. “Società di capitali con partecipazioni
paritetiche e stallo decisionale” cit., p. 160.
DOTTRINA EUTEKNE – RIPRODUZIONE VIETATA